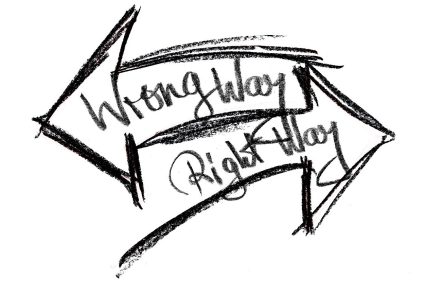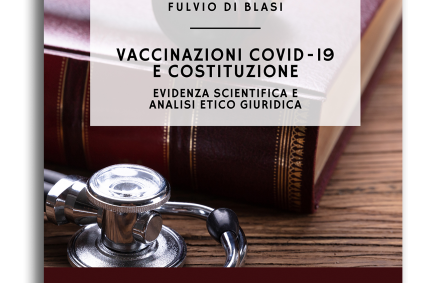Questioni di bioetica 1/2022
“A un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire l’ultima speranza”
Leonardo Sciascia
1. Il morire e le nostre paure
Due anni di pandemia hanno sconvolto le abitudini di vita della popolazione mondiale, soprattutto occidentale. Se la maggior parte delle persone ha accettato le drastiche limitazioni alla libertà di movimento imposte dalle misure di prevenzione dal contagio, ciò è avvenuto a causa della paura. Paura di essere contagiati e di contagiare. Ma soprattutto, in ultima analisi, paura di morire, di fronte a statistiche che, inesorabili, andavano comunicando il crescente numero di ricoveri in terapia intensiva e, soprattutto, di decessi. Anche ora che, nel succedersi delle varianti e con l’arrivo dei vaccini, si è compreso che per la maggioranza della popolazione il virus, pur essendo molto contagioso, non è letale, molti hanno continuato a temere il contagio come una sentenza di possibile morte, mentre altri, confidando nella scarsa letalità del virus, non lo considerano più pericoloso di una banale influenza.
Si profilano così, davanti ai nostri occhi, i due principali atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte. Il primo ritiene la morte un evento sempre possibile, senza illudersi che la buona salute di cui si gode sul momento sia una garanzia contro il rischio di morire per una qualsiasi causa, anche la più imprevedibile. Il secondo atteggiamento tende invece a rimuovere e a esorcizzare la possibilità della morte, considerandola un evento statisticamente diffuso, certo, ma che principalmente riguarda gli altri, non se stessi. Si muore ogni giorno, è vero. Ma non io, non adesso[1].
Eppure, quale che sia l’atteggiamento che si assume di fronte alla morte, l’antica saggezza ci insegna che la paura che ne abbiamo è del tutto infondata. Una paura, infatti, riguarda sempre qualcosa che c’è o ci sarà. Ma la morte non c’è, né mai ci sarà, ci rassicura il filosofo Epicuro. Finché siamo vivi, infatti, la morte non c’è. E quando c’è, siamo noi a non esserci[2]. Insomma: o noi o la morte, mai entrambi insieme. Della morte non si deve avere timore, dunque, perché la morte non è “qualcosa” che accada a chi sta vivendo, ma il puro e semplice non esserci più di chi un tempo ha vissuto. La morte non colpisce nessuno, perché nella morte non c’è più “qualcuno” che possa essere colpito. E come non avrebbe senso avere paura di qualcosa che non può accaderci, così nessuno di noi, conclude Epicuro, dovrebbe temere la propria morte.
È probabile che La Rochefoucauld pensasse proprio a Epicuro quando, con la sua consueta arguzia, ha affermato che non c’è miglior prova che la morte sia un male temibile della pena che i filosofi si sono dati per convincerci del contrario. Ciononostante non si può negare che il teorema epicureo, con tutti i suoi limiti, torni in qualche modo attuale nel moderno dibattito sulla “buona morte”. Chi sta soffrendo acutamente o prevede di soffrire senza speranza, infatti, trova qualcosa di “amichevole” nell’annullamento pacifico di cui parla Epicuro. In alcune circostanze della vita, in effetti, la “nera signora” non soltanto non ci fa paura, ma è addirittura invocata e desiderata. Sembra che la morte, in se stessa, non sia né buona né cattiva, e che dunque appaia, a seconda delle circostanze, ora come interruzione inopportuna della vita, ora come liberazione da una sofferenza altrimenti inguaribile. E dunque ora come una nemica, la più temuta e invincibile, ora come l’ultima alleata.
Quando vivere diviene opprimente e realmente insopportabile, la morte appare “buona”, perché ci offre la prospettiva di una liberazione che la metafora del sonno descrive con efficacia: “In te, morte, si posa nostra ignuda natura; lieta no, ma sicura dall’antico dolor”[3]. Lungi dal presentarsi come un puro e semplice annullamento della vita, come pensava Epicuro, la morte sembra qui offrire alla vita stessa l’ultimo riparo. E questo non soltanto nelle circostanze eccezionali di una particolare e inaspettata sofferenza, ma anche nel lento degradarsi provocato dalla vecchiaia. Così, per esempio, scrive Michel de Montaigne:
Ho notato che, più mi ammalo, più arrivo a nutrire una sorta di disprezzo nei confronti della vita. Mi accorgo di fare assai fatica a entrare in questa disposizione mentale quando sono sano che quando ho la febbre. Infatti, quando inizio a perdere l’uso e il gusto delle cose belle della vita, cesso di provare attaccamento per esse, e arrivo a guardare alla morte con meno timore. Ciò mi fa sperare che, quanto più mi distaccherò dalla vita e mi avvicinerò alla morte, tanto più facilmente accetterò lo scambio[4].
Il volto inaspettatamente amico della morte non ci impedisce di continuare a considerarla, tutto sommato, una sciagura. La morte continua a farci paura, inducendoci a considerare le situazioni in cui è desiderabile come delle eccezioni che confermano la regola. Da questa naturale e spontanea avversità nei confronti dell’annullamento della vita dipende il fenomeno, tipicamente moderno, della cosiddetta “rimozione sociale della morte”. La censura comincia già a livello lessicale. Quando muore qualcuno, l’affermazione “è morto” suona troppo dura e sconveniente, e si preferisce usare espressioni più generiche, come per esempio “se n’è andato”, “non c’è più”, “è scomparso” ecc.
Non a torto, Philippe Ariès ha potuto affermare che la morte occupa oggi il posto che occupava il sesso nella società vittoriana[5]. Un tempo, pur di non svelare il vergognoso retroscena del concepimento, si raccontava ai bambini della cicogna e della nascita sotto i cavoli, ma poi li si chiamava con naturalezza al capezzale del nonno, che li benediceva in punto di morte. Oggi l’educazione sessuale è entrata nelle scuole elementari, e tutti, sin dalla più precoce infanzia, sanno come nascono i bambini. Il tabù si è così spostato dall’inizio della vita alla sua fine: pur di evitare di parlare di “morte”, infatti, si racconta che il nonno è partito per un lungo viaggio[6]. Ciò è dovuto anche al fatto che si muore sempre più spesso in ospedale e nelle case di cura, lontano dalla vita di tutti i giorni. L’esperienza della morte è così sconosciuta a gran parte della popolazione, specialmente a quella più giovane[7]. Sempre più persone oggi muoiono senza aver mai visto, nella loro vita, qualcuno che muore. Tutto ciò contribuisce a rendere ancora più angosciante la paura della morte, della malattia e della vecchiaia, che non sono più esperienze socialmente condivise ma confinate nella sfera privata del singolo individuo[8].
2. Vivere e morire nell’epoca della medicina intensiva
All’odierno clima di rimozione psicologica e sociale della morte ha contribuito anche il sensazionale progresso medico e scientifico degli ultimi due secoli, che ha non solo aumentato la durata della vita ma anche migliorato la sua qualità. Se per un verso ciò ha allontanato lo spettro della morte, per altro verso lo ha reso più inquietante. Quando c’è tempo di affezionarsi a una vita tutto sommato gradevole, infatti, la morte fa più paura[9]. Ne abbiamo conferma se pensiamo che a causa dell’alta mortalità, anche infantile, in molte popolazioni dei paesi in via di sviluppo la morte è meno temuta di quanto non sia fra gli abitanti del Nord del mondo. Si potrebbe dire che la paura della morte è direttamente proporzionale al benessere della vita. Lì dove il benessere è irrimediabilmente perduto, la morte comincia non a caso a diventare “buona” (eu-tanasia). Così, come un tempo, a causa di una vita breve e dura, si invocava la “buona morte” da Dio, oggi, quando la malattia interrompe bruscamente una vita di qualità e la sofferenza si fa cronica, la si chiede al medico.
A complicare le cose, nel caso della medicina, è che la sofferenza della malattia è spesso un effetto “iatrogeno”, ossia una conseguenza provocata dalla medicina stessa[10]. Il decorso di malattie che un tempo conducevano rapidamente alla morte, come i tumori maligni, l’Aids e molte patologie del sistema cardiovascolare, respiratorio e nervoso, può oggi essere rallentato. Le tecniche di rianimazione e le apparecchiature di respirazione artificiale possono oggi sostituire le funzioni vitali di un organismo e mantenere in vita soggetti che, altrimenti, sarebbero morti. Questo ha risolto alcuni problemi ma ne ha anche creati altri. La medicina moderna rischia ormai di trasformare la morte, che prima era un evento più o meno puntuale, in un processo lungo e doloroso. Alcune patologie legate alla vecchiaia diventano croniche, radioterapia e chemioterapia, prolungando la vita, finiscono per prolungare anche le sofferenze e i disagi che la accompagnano nella sua fase terminale[11].
I problemi che nascono dalla cura delle persone che si trovano in condizioni critiche e con una qualità della vita gravemente compromessa erano un tempo risolti dalla natura stessa, in tempi e modi che lasciavano poca scelta ai medici[12]. Le possibilità di intervento della medicina moderna, invece, sono ormai tali, che in una elevata percentuale di casi la morte è più il risultato di decisioni umane che un evento naturale di cui, in passato, si era spettatori più o meno passivi. Che la morte giungesse “per natura” era da un lato un segno di impotenza per il medico, dall’altro lato era anche rassicurante, perché lo esonerava dalla responsabilità di una decisione altrimenti angosciosa. Oggi, invece, in situazioni di malattia e di sofferenza prolungate, il potere liberante della morte, rivelandosi sempre più un potere che si confonde con il nostro, grava la nostra responsabilità di un peso che solo una morte che arriva senza complicità umane sembra poter davvero sostenere. Se dunque nella nostra società il silenzio che consegue alla morte è così imbarazzato e imbarazzante, ciò avviene non soltanto per l’ormai nota incapacità di fronteggiare l’esperienza del lutto, ma anche perché dentro quel silenzio risuonano inquietanti domande su quanto la vita e la morte dell’altro, piuttosto che rispettate nel loro indisponibile accadere, siano state forzate dalle nostre decisioni[13].
3. Sofferenza e autodeterminazione del paziente
A sperimentare una certa forzatura è non soltanto chi è chiamato a prendersi cura, ma anche, e soprattutto, colui che soffre. Ed è qui che la libera autodeterminazione del paziente, solitamente presupposta come chiave risolutiva della moralità dell’eutanasia o del suicidio assistito, diventa essa stessa parte del problema. Ci si interroga per esempio sul reale grado di libertà di chi si trova in una condizione di tale sofferenza da ritenere preferibile la morte, e dunque su quanto sia effettivamente libera la scelta di morire da parte di chi la manifesta in preda ad acute sofferenze fisiche e a uno stato di cronica depressione psicologica.
Si profilano qui due posizioni. Secondo la prima, la principale causa della richiesta di morte è non tanto la sofferenza fisica, oggi trattabile con farmaci adeguati, ma la depressione psichica. Quest’ultima, tuttavia, sarebbe altrettanto gestibile tramite somministrazione di psicofarmaci, che non sono però quasi mai menzionati o proposti come terapia di prevenzione della domanda di morte, nel timore che ciò possa violare la dignità e l’autonomia del paziente. Secondo alcuni autori, però, proprio perché i disturbi psicologici – in questo caso dovuti alla malattia e alla sofferenza – alterano la capacità di intendere e di volere, la somministrazione di anti-depressivi sarebbe lecita anche senza il consenso del paziente, consenso che potrebbe essere ragionevolmente presunto[14].
La seconda posizione, ben espressa da un passaggio di un documento del Comitato Nazionale di Bioetica, è che la richiesta di morire, anche se condizionata dalla sofferenza e dalla malattia, rimane pur sempre libera:
Riconoscere la capacità di decisione delle persone in stato di grave sofferenza non significa negare l’influenza dell’emotività nelle scelte. È nel carattere degli umani l’essere guidati nelle loro azioni da sollecitazioni emotive che interagiscono con la razionalità. Ma ciò non inficia l’autodeterminazione, né può, di per sé, giustificare la limitazione della libertà delle persone sofferenti, pena l’aggiunta di nuove sofferenze[15].
Ogni atto umano, avrebbe detto Aristotele in quest’ottica, è “misto”, e cioè non è mai del tutto volontario né del tutto involontario. Il fatto che, senza un determinato condizionamento, non si sarebbe compiuta una certa scelta, non significa che quella determinata scelta non sia stata volontaria. Forse non si tratterà di una scelta totalmente libera, ma volontaria certamente sì. Se decido di prendere un farmaco a causa di un mal di testa, lo sto facendo volontariamente. Certo, se non avessi avuto alcun mal di testa non avrei preso alcun farmaco, ma questo non rende la mia decisione di prenderlo meno volontaria. È chiaro che se una scelta fosse libera solo perché non è influenzata in alcun modo né da bisogni e desideri né da timori e speranze, allora nessuna scelta umana sarebbe mai realmente libera, non soltanto quella di chi chiede di morire perché soffre troppo.
Ciò non esclude, naturalmente, che vi siano diversi gradi di libertà nelle nostre scelte, e che una decisione possa essere più o meno appesantita da fattori che sfuggono alla deliberazione dell’individuo coinvolto. Non a caso, la giurisprudenza sulle questioni di fine vita ha proposto il principio che “più grave è la decisione, maggiore deve essere la capacità richiesta” (more serious the decision, the greater the capacity required)[16].
4. Trattamento farmacologico e conforto esistenziale
Ben descrivendo l’ambivalenza, drammatica, del verbo “assistere” – che può significare tanto “stare a guardare” quanto “premurarsi” – è stato notato che
mentre a uno sguardo esterno il malato terminale appare come un moribondo, soggettivamente è un agonizzante, qualcuno che sta sperimentando un ultimo combattimento. Il rischio di chi è solo spettatore, sia pure spettatore qualificato, è assistere alla morte senza assistere il morente[17].
Il termine “agonia” ci ricorda in effetti che c’è sempre, nella morte, un aspetto di violenza, che non ha niente a che vedere con l’annullamento rassicurante di cui parlava Epicuro. Soprattutto nell’imminenza dell’ultimo istante, per chi ha la fortuna – o la sfortuna – di viverlo consapevolmente, sembra che l’individuo avverta un inesorabile moto di avvicinamento, di cui l’angoscia è la misura psicologica.
Come ha sottolineato acutamente il filosofo francese Emmanuel Lévinas, ultima latet: la minaccia della morte, quando è ormai chiaro il suo approssimarsi, non viene da un punto preciso dell’avvenire. Il carattere imprevedibile degli ultimi istanti non dipende da un difetto prognostico, ma dalla natura stessa del morire, che non è mai un semplice annullamento, ma qualcosa che si avvicina e che ci prende senza lasciarsi prendere. L’imminenza della morte sancisce la nostra più totale passività e impotenza. Una volta che si sia fatto tutto il possibile, con una morte imminente non si può più “lottare”. Nella lotta, infatti, io riesco ad afferrare chi mi prende, mentre qui è come trovarsi al buio sapendo che il nemico può colpire, silenzioso, da qualunque direzione. Anche quando è prevista e prevedibile, la morte ha sempre l’aspetto di un “agguato”, di “un omicidio nella notte”, come se non fosse un evento naturale o un cieco destino, ma esprimesse l’ostilità di qualcuno, di «un volere maligno che sorprende e sta in agguato»[18]. Negli ultimi giorni della mia vita, contrariamente a quanto pensava Epicuro, «non sono di fronte al nulla, ma di fronte a ciò che è contro di me»[19]. Morire fa paura, insomma, perché significa non già svanire nel nulla, ma essere aggrediti da qualcosa.
In questo scenario di radicale passività e impotenza, ciò che della morte si lascia ancora trattare è la sofferenza che l’accompagna. È la sofferenza del trapasso, infatti, a dare alla morte il suo caratteristico aspetto minaccioso. La sofferenza terminale è l’oscuro presagio della morte. Nell’ottica delle cure palliative, eliminare questa sofferenza con l’eutanasia significherebbe in qualche modo lasciare potere di iniziativa e primato alla morte stessa. Significherebbe riconoscere che l’unico modo di scongiurarla sia anticiparla. La peculiare sfida raccolta dalla medicina palliativa consiste invece nel trattare la sofferenza terminale mantenendosi equidistante dai due opposti e sbrigativi tentativi di esorcizzare la morte: l’eutanasia e l’accanimento terapeutico. La filosofia delle cure palliative segue la massima: né anticipare né rinviare ma accompagnare, e cioè camminare accanto senza imporre il proprio passo[20].
Ora, ciò che si chiede quando si invoca la morte, spesso, non è semplicemente di morire, ma di vivere dignitosamente gli ultimi momenti della vita. Quando ciò non avviene e la vita del paziente è solo preservata e non anche migliorata, egli potrebbe essere nuovamente indotto a chiedere la morte, sperimentando l’opposizione dei medici e dei parenti come una “condanna” a vivere nella sofferenza. Per questo un rifiuto dell’eutanasia che non prenda sul serio i motivi che spingono il paziente a richiederla e che non gli offra un’alternativa adeguata non è credibile, potendo apparire, al limite, anche disumano.
Com’è risaputo, il tentativo più organizzato e capillare di prendere sul serio il dolore e la sofferenza del malato, soprattutto terminale, è rappresentato dalla medicina palliativa. L’aggettivo “palliativo” deriva da pallium, il mantello che nell’antichità serviva a proteggere, a coprire e a riscaldare. Con l’immagine del mantello si intende esprimere il lenimento con cui si “copre” una malattia che purtroppo procede inesorabilmente, ma i cui sintomi, almeno, sono attenuati nell’ottica di promuovere un’accettabile qualità della vita per il malato[21].
Promossa specialmente per iniziativa dell’Hospice Movement, sviluppatosi in Inghilterra negli anni Sessanta, la medicina palliativa ha posto il problema di “cosa si può fare quando non c’è più niente da fare”[22]. La frequente espressione “non c’è più nulla da fare”, in effetti, si riferisce al mancato successo terapeutico, non all’attività di cura. Si dice, in tal senso, che se esistono malati “inguaribili” non ne esistono però di “incurabili”. Il compito della medicina, lo si è ricordato, è non solo “sanare infirmos”, ma anche “sedare dolorem”. E anche se talvolta il medico tende a considerare il secondo compito qualcosa di meno gratificante rispetto al primo, perché privo del “successo” terapeutico che sembra dare maggior merito al suo intervento, il trattamento del dolore è «parte integrante di ciò che una persona può e deve aspettarsi dalla medicina e dai sanitari»[23].
Il principio di fondo della medicina palliativa è che dopo aver esaurito tutte le possibilità terapeutiche, anziché ostinarsi a respingere una morte inevitabile con un dispiegamento di interventi e di mezzi tanto inutili quanto dispendiosi, occorra privilegiare la qualità dell’assistenza al malato e ai suoi familiari[24]. La medicina palliativa si basa cioè sull’idea che l’arte medica, dopo aver aiutato gli uomini a nascere, deve aiutarli alla fine anche a morire[25]. Così, anche quando il medico non può più guarire la malattia, deve comunque prendersi cura del malato con opportuni interventi che consentano di alleviare le sue sofferenze e di rendere il suo incontro con la morte meno straziante[26].
Esiste oggi un modo efficace, semplice e sicuro di combattere il dolore fisico, ed è quello di usare in modo corretto e tempestivo i farmaci analgesici, secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità[27]. Gli analgesici sono farmaci in grado di diminuire e di abolire il dolore fisico. I due gruppi principali sono i farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), che agiscono a livello periferico riducendo la liberazione di sostanze che stimolano i recettori del dolore; e gli oppioidi, derivati dai principi attivi contenuti nell’oppio. Gli oppioidi agiscono a livello del sistema nervoso centrale, riducendo o eliminando la percezione del dolore[28]. Il farmaco oppioide più potente è la morfina, l’unica capace, per esempio, di combattere il dolore più temuto in fase terminale: la dispnea[29].
I sostenitori dell’Hospice movement riferiscono di molti pazienti che, inizialmente tentati di chiedere l’eutanasia, una volta sottoposti a un adeguato piano di cure palliative non hanno più desiderato la morte. In un documento del St-Christopher’s Hospital di Londra, un centro all’avanguardia nel trattamento del dolore, si afferma che «Se un malato chiede l’eutanasia, è perché qualcuno ha mancato e, in molti casi, questo qualcuno è il medico. Molto spesso si può tradurre la domanda ‘mi faccia morire’ con ‘dia sollievo al mio dolore e mi ascolti’. Se si soddisfano questi due bisogni, la richiesta di solito non sarà reiterata»[30].
Non è detto che le cose funzionino sempre così linearmente, certo. Né sarebbe giusto ritenere, come si legge nel documento, che se un paziente chiede di morire ciò avviene perché qualcuno ha mancato. Può darsi, ma non necessariamente. Ci sono persone che chiedono di morire nonostante siano circondate dall’affetto e dalla premura di medici e familiari. È vero che si tratta di casi molto rari, e che in genere la medicina palliativa riesce a prevenire la richiesta di morte da parte del paziente[31]. I farmaci analgesici, in effetti, risultano efficaci nel 90% dei casi[32], e nella restante percentuale, che include i casi più estremi come delirium, emorragie, vomito incoercibile e dispnea, è sempre possibile, con il consenso del paziente e/o dei familiari, il ricorso alla sedazione palliativa profonda. A esclusione di qualche caso eroico, in cui il paziente preferisce rimanere lucido fino alla fine, di fronte all’intensità di certi dolori il paziente, in genere, chiede o accetta di essere sedato.
5. Terapia del dolore e azione a “duplice effetto”
Com’è noto, a causa di determinati effetti collaterali, tra i quali la depressione respiratoria e la farmacodipendenza, la pratica della sedazione e della terapia del dolore nelle fasi terminali tocca uno dei nodi più dibattuti dell’etica di fine vita[33]. Più concretamente, si tratta di capire il grado di responsabilità del medico di fronte a due situazioni in cui il suo agire o non agire ha un duplice effetto:
a) il rifiuto o la sospensione di terapie da cui consegue la morte del paziente;
b) la somministrazione di dosi sempre più elevate di sedativi e antidolorifici che possono, fra gli effetti possibili, abbreviare la vita del paziente.
La linea prevalente, al riguardo, è che la morte del paziente, in entrambi i casi, possa essere giustificata solo come un effetto previsto, ma non direttamente voluto, sia dell’azione di sottrarre terapie sproporzionate, sia dell’azione di somministrare analgesici.
Discutendo questo aspetto, gli studiosi di bioetica parlano di “azione a duplice effetto”, e si chiedono a quali condizioni può essere lecito compiere un’azione che ha sia un effetto positivo (sedare il dolore) sia un probabile effetto negativo (provocare la morte). Il dibattito bioetico sull’effettiva rilevanza morale e medico-legale della sedazione profonda dipende da questa specifica difficoltà: capire se si può provocare deliberatamente l’effetto positivo senza essere ritenuti responsabili di aver provocato altrettanto deliberatamente quello negativo.
In base al cosiddetto “principio dell’atto a duplice effetto”[34], implicitamente contenuto in molte legislazioni e negli stessi codici di diritto penale, un’azione che ha un effetto positivo e uno negativo è lecita, ma a condizione che:
a) non vi siano alternative che consentano di provocare solo l’effetto positivo senza quello negativo (il dolore del paziente deve essere incoercibile e non altrimenti trattabile);
b) che via sia una proporzione fra lo scopo buono che si intende perseguire e l’effetto dannoso che si è disposti a tollerare (la morte deve essere talmente imminente e dolorosa da giustificare una sedazione che rischia di anticiparla);
c) che l’effetto dannoso non sia il mezzo per ottenere quello benefico (la morte eventualmente provocata non deve essere il mezzo con cui si eliminano le sofferenze).
Si tratta di capire, essenzialmente, se sia accettabile un’azione che, oltre all’effetto positivo di alleviare il dolore, abbia anche l’effetto negativo di abbreviare la vita.
Com’è risaputo, in molti casi il processo che conduce alla morte un malato cronico è lento e penoso. Se il paziente chiede che i suoi dolori siano alleviati con gli opportuni rimedi, le possibilità di intervento sono generalmente due, legate alla situazione specifica del paziente:
a) la somministrazione discontinua e periodica di analgesici, con alterne fasi di lucidità e appannamento della coscienza;
b) la somministrazione continua e progressiva di sedativi, al limite fino alla perdita della coscienza e al rischio di arresto cardiaco (la cosiddetta “sedazione terminale”).
Ora, poiché con l’approssimarsi della morte il dolore spesso aumenta e poiché molti degli analgesici usati nelle fasi terminali producono assuefazione, per garantire la loro efficacia è necessario aumentarne la dose. Al paziente può dunque essere proposto di incrementare la somministrazione, per esempio, di morfina, benché questo aumento di dosaggio possa comportare, come effetto collaterale, anche la morte. Spesso il malato e i familiari accettano e, dopo qualche giorno di terapia del dolore, può sopraggiungere la morte per l’effetto combinato della patologia e delle dosi massicce di morfina.
Una possibile indicazione per fare chiarezza su queste fattispecie medico-legali proviene dallo stesso Codice di deontologia medica (2014), in cui, dopo aver precisato che «il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocare la morte» (art. 17), si ammette che «i trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica» possono essere «attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona» (art. 18). Quando dunque produce due effetti distinti, da una parte l’alleviamento dei dolori e dall’altra un’abbreviazione della vita, la sedazione è lecita, a condizione che i vantaggi dell’effetto positivo compensino gli inconvenienti di quello negativo[35].
Certo, per coloro che ritengono lecito provocare intenzionalmente la morte del paziente terminale il problema non si pone. E sono proprio i sostenitori della “buona morte” a identificare la sedazione terminale con l’eutanasia, ben sapendo che, così facendo, otterranno un duplice vantaggio: per un verso far vedere che l’eutanasia, pur formalmente vietata, è materialmente già praticata; per altro verso evidenziare l’ipocrisia di un ordinamento giuridico che autorizza sottobanco ciò che vieta alla luce del sole. Quando un paziente muore prima del tempo per effetto degli analgesici, peraltro, dire che i medici non si sono posti come obiettivo la morte del paziente ma che questa è stata solo prevista e accettata come effetto collaterale suona, per alcuni, come un escamotage, che mira più a difendere i medici e i parenti da procedimenti giudiziari che il paziente dalla sofferenza[36].
Qual è il fondamento dell’equiparazione fra sedazione palliativa, o somministrazione piramidale di morfina, ed eutanasia? Secondo i sostenitori di questa equiparazione,
L’effettiva azione di iniettare la morfina, che il dottore ha compiuto direttamente, gioca un ruolo nel determinare la morte del paziente. La sequenza causale aperta dall’insorgere della malattia del paziente non prosegue ininterrotta fino al sopraggiungere della morte. Al contrario, un atto diretto del dottore interviene in questa sequenza originale, e tale atto avvia una nuova catena causale alla fine della quale vi è la morte del paziente per crisi respiratoria[37].
Una simile argomentazione poggia sul fatto che il decesso del paziente è sotto il controllo del soggetto agente, che avrebbe potuto astenersi dal provocarlo. Così, «Se un agente sceglie deliberatamente di compiere un’azione A con il desiderio di produrre l’effetto P, ma sa che l’azione produrrà al tempo stesso l’effetto Q, egli è ugualmente responsabile per P e per Q, poiché ha scelto di fare ciò che poteva astenersi dal fare»[38]. Sarebbe irresponsabile, in quest’ottica, concentrarsi più sul tipo di azione che i sanitari devono o non possono compiere che sul bene del paziente. La critica rivolta a chi invece sostiene la teoria dell’azione a duplice effetto è che «in alcuni casi l’adesione a una purezza personale, il desiderio di non fare certe azioni può segnalare più una forma di autocompiacimento che una coraggiosa capacità di affrontare le difficoltà delle situazioni»[39].
A ben vedere questo genere di obiezioni non tiene conto del fatto che ci sono situazioni,e il principio del duplice effetto si applica soprattutto a queste, in cui, qualunque cosa uno faccia, provocherà un danno. Far notare che il medico che somministra la morfina per alleviare i dolori e non per uccidere è comunque responsabile della morte del paziente perché avrebbe potuto astenersi dal somministrarla, non tiene conto che se si fosse astenuto egli sarebbe stato comunque responsabile della sofferenza del malato[40], dal momento che questa sofferenza si sarebbe potuta evitare solo somministrando morfina.
Come si può vedere, qui il soggetto chiamato ad agire può, con la sua azione/omissione, scegliere di provocare deliberatamente due situazioni: ouna in cui il malato soffre fino a morire, o una situazione in cui il malato morirà comunque ma senza soffrire. L’alternativa è dunque o sofferenza + morte o sollievo dalla sofferenza + morte. La morte è presente in entrambi i casi, per cui la ragione per cui si sceglie un caso piuttosto che l’altro non potrà appellarsi al fatto che il paziente morirà o al momento in cui lo farà, ma solo alla presenza o all’assenza di sofferenza associata a questo inevitabile processo. Nel caso in cui, con la sedazione, si scegliesse la seconda opzione, non si sceglierebbe perciò la morte – che è inevitabile e presente in entrambe le opzioni – ma il sollievo dalla sofferenza. Analogamente, se si scegliesse la prima opzione non si sceglierebbe la morte, ma la sofferenza[41].
Una volta che si sia riconosciuto che il problema, nel caso dei pazienti terminali, non è quello di evitare la morte a ogni costo ma quello di far sì che essa giunga nel modo più conforme alla dignità della persona, qualunque medico si rende conto, abbastanza facilmente, che somministrare dosi progressive di morfina per alleviare il dolore e somministrare un farmaco letale sono due azioni moralmente diverse. Una cosa, infatti, è decidere di correre il rischio di provocare la morte pur di alleviare il dolore (dosaggio progressivo di morfina), altra cosa è decidere di uccidere con lo scopo di eliminare il dolore (iniezione letale).
A dispetto di queste precisazioni, altri studiosi obiettano che distinguere, all’interno della medesima azione, due effetti, uno voluto come scopo e l’altro previsto solo come conseguenza collaterale, non regge per due motivi.
In primo luogo quando si somministrano forti dosi di analgesici che hanno sia l’effetto di placare il dolore sia quello di abbreviare la vita del paziente, non c’è modo di verificare se l’intenzione del medico è effettivamente quella di alleviare le sofferenze e non quella di provocare la morte.
In secondo luogo, se l’intenzione di alleviare le sofferenze di un paziente giustifica moralmente un’azione da cui consegue la sua morte, allora anche il medico che pratica un’iniezione letale, non volendo realmente la morte del paziente, ma soltanto l’alleviamento delle sue sofferenze, sarebbe pienamente giustificato[42]. Effettivamente, se tutto dipendesse dall’intenzione soggettiva, allora non sarebbe più possibile distinguere ciò che è eutanasia da ciò che non lo è, e qualunque azione sarebbe ugualmente lecita una volta appurato che lo scopo è quello, senz’altro lodevole, di eliminare le sofferenze del malato.
In realtà, il criterio per stabilire se una determinata azione è o non è una forma di eutanasia non si basa solo sull’intenzione del medico e del paziente, ma anche sulla natura del mezzo impiegato. Chi agisce, infatti, vuole non soltanto il fine (eliminare le sofferenze), ma anche i mezzi adatti a raggiungerlo (dose palliativa di analgesici o iniezione letale).
Come si è detto, affinché l’azione di rimuovere il dolore del paziente possa essere giustificata in base al “principio del duplice effetto”, l’effetto negativo (la morte del paziente), non deve essere il mezzo scelto dal medico per ottenere quello positivo (la rimozione del dolore). Se così fosse, infatti, la morte del paziente sarebbe positivamente voluta, benché non come fine ma come mezzo, pur di ottenere lo scopo di eliminarne le sofferenze. In realtà l’effetto primario dei farmaci analgesici non è propriamente la morte del paziente ma l’alleviamento delle sue sofferenze. Se, in seguito, subentra anche la morte del paziente, non si tratterebbe di un effetto voluto, né come fine né come mezzo, ma soltanto previsto e accettato, come dimostra il fatto che il controllo del dolore consegue all’uso del sedativo prima ancora che il paziente muoia. Nel caso dell’eutanasia, invece, la morte non è una conseguenza aggiuntiva e non voluta della propria azione o omissione, ma il mezzo che si sceglie deliberatamente di utilizzare per raggiungere lo scopo di eliminare le sofferenze del paziente.
6. La sedazione palliativa profonda:
una forma di eutanasia mascherata?
Quanto si è appena precisato è oggetto di ampie discussioni soprattutto nell’ambito della sedazione cosiddetta “terminale”.
L’aggettivo “terminale” è a dire il vero ambiguo, perché può riferirsi sia alla prognosi del tempo di vita rimasto al paziente (che va da un minimo di poche ore a un massimo di due settimane), sia al possibile effetto letale della stessa sedazione[43]. Per questo motivo, alcuni ritengono la sedazione terminale come una slow euthanasia, o comunque una forma mascherata di eutanasia. Altri, anche rifacendosi al “principio dell’azione a duplice effetto”, escludono che la sedazione terminale abbia lo scopo di porre fine alla vita del paziente. In questo caso, infatti, essendo somministrati non in dose letale ma in una dose proporzionata al controllo del dolore, i sedativi hanno lo scopo non di far morire il paziente – come avviene nell’eutanasia – ma di alleviare le sue sofferenze.
Anche l’European Association of Palliative Care ritiene che la sedazione terminale non equivalga a una forma di eutanasia[44], e ciò sarebbe confermato dal fatto che la durata media della sopravvivenza dei pazienti sedati in fase terminale non è sostanzialmente diversa da quella di pazienti non sedati[45]. Con un’espressione meno agile e un po’ faticosa, ma concettualmente e clinicamente più rigorosa, si preferisce pertanto parlare di “sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte”[46], ossia di una pratica il cui scopo specifico, diversamente da quello dell’eutanasia, non è di “far morire” chi sta soffrendo, ma di “far dormire” chi sta morendo, risparmiandogli le pene che altrimenti lo strazierebbero negli ultimi giorni di agonia. Si potrebbe dire che, nel trattare il dolore di chi sta per congedarsi dalla vita, la sedazione palliativa è una forma di compassione “in punta di piedi”: non anticipa la morte né la rimanda, ma la asseconda umanizzandola. Tornando alla metaforica associazione fra il morire e il dormire – che qui è ben più che una metafora – si potrebbe dire che il compito della sedazione consista nel “silenziare” la morte, nel toglierle il tratto straziante dello sradicamento violento per restituirle quello, pacifico, del sonno liberatorio.
Dal punto di vista più propriamente medico, visto il suo carattere di fatto irreversibile, la sedazione profonda deve essere somministrata solo dopo un’attenta e prudente valutazione delle condizioni cliniche e psicologiche del paziente. Secondo un parere pubblicato nel 2016 dal Comitato Nazionale per la Bioetica, tali condizioni sono le seguenti:
1) una malattia inguaribile a uno stadio avanzato;
2) una morte imminente;
3) la presenza di sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con sofferenza intollerabile;
4) il consenso informato del paziente, dov’è possibile ottenerlo, o, in caso di incapacità, dei suoi familiari.
Queste condizioni riprendono quanto era stato già affermato qualche anno prima nelle Raccomandazioni sulla Sedazione Terminale/Palliativa, Ottobre 2007, a cura della Società Italiana di Cure Palliative[47], per la quale la distinzione fra sedazione palliativa ed eutanasia si basa su tre elementi costitutivi della procedura terapeutica:
- obiettivo (intenzione);
- tipo di farmaci, dosaggio e via di somministrazione impiegati;
- risultato finale.
Ne consegue che:
- Nella sedazione palliativa l’obiettivo è rappresentato dal controllo dei sintomi refrattari e non dall’induzione della morte del malato, come invece è nell’eutanasia;
- Quanto ai i tipi di farmaci, dosaggio e via di somministrazione sono finalizzati al miglior controllo dei sintomi attuabile e non alla rapida induzione della morte, come invece accade nell’eutanasia.
- Risultato della procedura: nella sedazione palliativa esso coincide con l’abolizione della percezione, mentre nell’eutanasia coincide con la morte del malato.
Va precisato, a tale proposito, che quando l’European Association of Palliative Care afferma che la sedazione terminale non va confusa con l’eutanasia perché la durata media della sopravvivenza dei pazienti sedati in fase terminale non è sostanzialmente diversa da quella di pazienti non sedati, si riferisce all’uso esclusivamente palliativo della sedazione. La sedazione terminale, tuttavia, può essere utilizzata non soltanto per alleviare il dolore, ma anche per anticipare la morte. Magari giocando sulla difficoltà di distinguere fra un decesso dovuto alla patologia di cui il paziente già soffre e quello indotto dalla progressiva somministrazione di farmaci, soprattutto quando è presente anche morfina.
Una simile obiezione si basa su un presupposto erroneo, che consiste nell’attribuire un valore assoluto alla vita biologica, per poi considerare tutte le azioni mediche non direttamente finalizzate a preservarla come una violazione del dovere di farlo. In realtà, se il compito del medico non è di prolungare la vita a qualunque costo ma di guarire i malati o, nell’impossibilità di farlo, di alleviare il dolore, allora di fronte a un malato inguaribile e terminale è lecito e ragionevole combattere il dolore anche a costo di abbreviare la vita.
Da questo punto di vista, e ben al di là di determinate sottigliezze medico-legali, qualunque medico si rende conto, abbastanza facilmente, che somministrare dosi progressive di farmaci per alleviare il dolore e somministrare un farmaco letale sono due azioni moralmente diverse[48]. Una cosa, infatti, è decidere di correre il rischio di anticipare una morte comunque imminente pur di alleviare il dolore (dosaggio progressivo di sedativi), altra cosa è decidere di uccidere con lo scopo di eliminare il dolore (iniezione letale). Dato per scontato lo scopo di eliminare le sofferenze – che accomuna favorevoli e contrari all’eutanasia – il criterio per stabilire ciò che è eutanasia da ciò che non lo è si basa dunque non solo sull’intenzione di chi agisce, ma anche sui metodi usati.
Che in determinate circostanze cliniche la sedazione possa avere, oltre all’effetto di alleviare il dolore, anche quello di abbreviare la vita, dimostra che quanti la ritengono una forma camuffata di eutanasia non abbiano del tutto torto. A ben vedere, molto dipende dall’uso che facciamo dei farmaci e dalle intenzioni che abbiamo nel somministrarli. Ed è evidente che, di per sé, la sedazione palliativa profonda non ha lo scopo di porre fine alla vita del paziente, poiché i farmaci utilizzati – principalmente la benzodiazepina e raramente la morfina – non sono somministrati in dosi letali, ma in una dose proporzionata al controllo del dolore. La sedazione, come si diceva, non ha lo scopo di far morire il paziente, ma di assopirne la coscienza per alleviare le sue sofferenze.
Ridurre la valutazione della sedazione palliativa agli aspetti medico-legali significherebbe concentrarsi troppo sull’agire medico, trascurando il ben più rilevante punto di vista del paziente e dei suoi familiari. Bel oltre gli aspetti farmacologici della sedazione palliativa, in effetti, ne esistono anche di esistenziali e relazionali. Proporre a un malato ancora lucido una sedazione “terminale”, infatti, potrebbe acuire il senso di disperazione e d’ineluttabilità della morte ravvicinata, con conseguenze di non poco rilievo sul distress complessivo. Il rischio che si corre, in questi casi, è che all’offerta di un sollievo totale da una sofferenza non più sostenibile, si accompagni un momento, altrettanto doloroso, d’angoscia e di sconforto di fronte a una scelta che, di fatto, rappresenta l’addio del malato alla vita e agli affetti che lo circondano[49]. A questo riguardo, e contrariamente a quanto spesso si sente dire, la sedazione palliativa non priva il malato della possibilità di vivere consapevolmente la propria morte, semplicemente anticipa questo momento, perché tale è la situazione di chi, pur sapendo che la sedazione non determinerà oggettivamente la morte, soggettivamente è come se lo facesse. A differenza che negli animali, infatti, negli esseri umani morire è non soltanto lo spegnimento fisico della funzionalità biologica dell’organismo, ma anche e soprattutto la perdita definitiva della coscienza.
Certo, quest’ultima osservazione potrebbe indurre a considerare la sedazione palliativa come una forma di eutanasia non biologica ma psicologica. E in parte lo è. A condizione, però, di considerare tale anche una semplice anestesia chirurgica. All’obiezione che la sedazione profonda sarebbe definitiva e irreversibile mentre quella chirurgica solo provvisoria e reversibile, si può replicare che a rendere definitiva e irreversibile la sedazione palliativa non sono i farmaci, ma il fatto che, a un certo punto, interverrà la morte biologica, che però, per i motivi già evidenziati, non sarebbe direttamente provocata dalla sedazione.
Come si può vedere, lungi dall’essere una medicina di serie B o un ripiego che subentra solo dopo il fallimento della vera medicina, la medicina palliativa rivela l’essenza morale di qualunque atto medico, che è “trattamento” della malattia solo in quanto è anche, e prima ancora, impegno di cura e di prossimità nei confronti di una persona che soffre. Continuare ad aver cura (to care) anche quando non si può più guarire (to cure), significa infatti che il medico ha a che fare principalmente non con una malattia ma con una persona malata. È la celebre differenza fra trattamento della malattia (curing) e attenzione al malato (caring). La medicina palliativa è, in tal senso, medicina per eccellenza, perché è il luogo in cui la scienza, incontrandosi con la pietà, mostra il vero volto della medicina in generale, la quale, al di là dell’arsenale diagnostico-terapeutico di cui dispone, è pur sempre ciò che era già ai tempi di Ippocrate, ossia una forma di compassione istituzionalizzata.
*Questo articolo riprende una relazione originariamente presentata, con il titolo “I live, therefore I die”, al Convegno Internazionale “Simply the Best” su Terapia del dolore e cure palliative, organizzato dal Dipartimento di Oncologia della Clinica Maddalena di Palermo, dalla Samot-Sicilia e dal MD Anderson Cancer Center University of Texas.
[1] Questo duplice atteggiamento è reso possibile dalla natura ambivalente della morte, e cioè di quel paradossale evento in cui l’unica cosa certa della vita è al tempo stesso quella su cui non possiamo avere alcuna certezza. Così, mentre i timorosi enfatizzano la certezza dell’evento, gli audaci giocano sulla sua incertezza.
[2] Epicuro, Epistola a Meneceo, in Id., Lettere. Sulla fisica, sul cielo e sulla felicità, Rizzoli, Milano 1996, p. 124.
[3] G. Leopardi, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, in Id., Canti, Operette morali, Memorie e Pensieri d’amore, Einaudi, Torino 2005, p. 479. Cfr. anche S. Kierkegaard, Accanto a una tomba, Il melangolo, Genova 1999, p. 49, dove il non riuscire a morire è presentato come una condizione di disagio e di angoscia analoga a quella di chi, sfibrato dalla stanchezza, fatica a trovare la giusta posizione per abbandonarsi al sonno.
[4] M. De Montagine, Saggi, Bompiani, Milano 2012, pp. 370-371.
[5] Ph. Ariès, Storia della morte in Occidente, Il Mulino, Bologna 1976, p. 73.
[6] Ibidem.
[7] F. Toscani, Il malato terminale, Il Saggiatore, Milano 1997, p. 18.
[8] E. Kübler-Ross, La morte e il morire, Cittadella, Assisi 2005; Ch. Jomain, Vivere l’ultimo istante, Paoline, Milano 1987 e M. De Hennezel, La morte amica, Rizzoli, Milano 1998 e Id., Morire a occhi aperti, Lindau, Torino 2006. Secondo alcuni studiosi la “solitudine dei moribondi” rispecchia la solitudine dei vivi: il modo di morire soli, in una stanza di ospedale, non dipende solo dalla medicalizzazione della vita e della morte, ma anche dal modo individualistico di vivere. Cfr. N. Elias, La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna 1985.
[9] R. Bodei, L’epoca dell’antidestino, in D. Monti (a cura di), Che cosa vuol dire morire, Einaudi, Torino 2010, pp. 53-78: 69.
[10] I. Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mondadori, Milano 1977.
[11] Cfr. P. Becchi, Cos’è la bioetica. Temi e problemi, Giappichelli, Torino 2019, pp. 61 ss.
[12] G. Seay – S. Nuccetelli, When Life Supports Are Futile or Refused, in G. Seay – S. Nuccetelli, Engaging Bioethics. An Introduction with Case Studies, Routledge, London 2017, p. 138.
[13] Nella recente proposta di legge sull’eutanasia legale in discussione nel Parlamento italiano troviamo un tentativo di esorcizzare questo disagio nella decisione di considerare “naturale” la morte che consegue al suicidio assistito o a eutanasia (Camera dei Deputati, Commissioni Riunite Giustizia e Affari Sociali, Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, art. 5, c. 8 su http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/07/06/leg.18.bol0618.data20210706.com0212.pdf). Interessanti, al riguardo, le ricerche sull’elaborazione del lutto dei parenti e amici di persone decedute in seguito a eutanasia e suicidio assistito, che differisce da quello elaborato in circostanze di morte naturale. Cfr. K. Andriessen, K. Krysinska, D.A. Castelli Dransart, L. Dargis, B.L. Mishara, Grief after euthanasia and physician-assisted suicide: A systematic review, “Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention”, 41(2020) 4, pp. 255-272.
[14] Cf. G. Bersani – R. Rinaldi – A. Innaitelli, Il suicidio assistito degli italiani in Svizzera e il silenzio della psichiatria, “Rivista di Psichiatria”, 53 (2018) 4, pp. 173-176.
[15] Comitato Nazionale per la bioetica, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, 18 luglio 2019, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2019, p. 14.
[16] Re C (Adult: Refusal of Treatment, 1994, 1 WLR, p. 290, cit. in S. Amato, Eutanasie. Il diritto di fronte alla fine della vita, Giappichelli, Torino 2011.
[17] M.T. Russo, La morte e il morire: un problema tecnico o una questione di senso? “Medic”, 25 (2017), 2: pp. 63-68.
[18] E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1991, pp. 239-240.
[19] Ivi, p. 240.
[20] C. Viafora, L’etica dell’accompagnamento: un altro sguardo sulla fase terminale, in C. Viafora, A. Gaiani (a cura di), A lezione di bioetica. Temi e strumenti, Franco Angeli, Milano 2015,pp. 295-314: 300.
[21] P. Cattorini, Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Edra, Milano 2016, p. 67.
[22] E. Montaguti, La “buona morte”. Analisi del profilo storico e ruolo delle cure palliative, Mimesis, Milano 2020.
[23] Comitato Nazionale per la Bioetica, La terapia del dolore: orientamenti bioetici, 30 marzo 2001, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001. Prendere sul serio il dolore, anche quando non è sintomo di una malattia, si traduce nell’obbligo, previsto dalla legge 38/2010(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), di riportarlo in cartella clinica (art. 7).
[24] B. Ars – E. Montero, Introduzione, in B. Ars – E. Montero (a cura di), Eutanasia. Sofferenza & dignità al crepuscolo della vita, Ares, Milano 2005.
[25] E. Schockenhoff, Etica della vita. Un compendio teologico, Queriniana, Brescia 1997, p. 315.
[26] L. Alici, Il fragile e il prezioso. Bioetica in punta di piedi, Morcelliana, Brescia 2016, p. 81.
[27] Cf. World Health Organization, Integrating palliative care and symptom relief into the response to humanitarian emergencies and crises: a WHO guide, 2018, https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2018/12/155_whopchumanitarianemergencies18.pdf
[28] F. Toscani, Il malato terminale, Il Saggiatore, Milano 1997, p. 103.
[29] Quando la somministrazione per via orale e parenterale non è più praticabile si procede a una somministrazione per via spinale o, in certi casi, come nella sclerosi laterale amiotrofica, alla tracheotomia.
[30] Cfr. M.C. Comby – M. Filbet, The demand for euthanasia in palliative care units: a prospective study in seven units of the “Rhone-Alpes” region, “Palliative Medicine”, 2005, 19 (8): pp. 587-593.
[31] C. Saunders – M. Baines, Living with Dying. The management of terminal disease, Oxford, Oxford University Press 1983; F. Henriquet, La trama delle cure nella medicina palliativa, “L’Arco di Giano” 14, 1997, pp. 115-126.
[32] Queste percentuali sono riportate anche da coloro che ritengono lecita l’eutanasia. Cfr. Sherwin B. Nuland, Il medico e il paziente di fronte alla morte, Fondazione Sigma-Tau, Roma 2001.
[33] E. Wesley – E. Azoulay – Ch. Sprung, Distinction between good palliative care and intending death, “Intensive Care Medicine”, 46 (2020), 1: pp. 147-148; P. Allmark – M. Cobb – J.B. Liddle – A.M. Tod, Is the doctrine of double effect irrelevant in end-of-life decision making? “Nursing Philosophy”, (2010), 11: 170-177 e V. Cellarius, Terminal sedation and the imminence condition, “Journal of Medical Ethics”, 34 (2008), pp. 69-72.
[34] Storicamente il principio del doppio effetto nasce dalle discussioni filosofico-teologiche del XVI e XVII secolo, che riprendevano, aggiornandola, la teoria di Tommaso d’Aquino sul “volontarium indirectum”, o “legittima difesa”, e cioè sulla giustificazione di azioni con cui ci si può difendere solo provocando la morte di un ingiusto aggressore, la cui morte non è voluta direttamente da chi si difende, ma solo accettata a malincuore come effetto indiretto del vero scopo della propria azione, che è di proteggere se stessi (cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q. 64, a. 7). Sul tema si veda T.A. Cavanaugh, Double-Effect Reasoning: Doing Good and Avoiding Evil, Clarendon Press, Oxford 2006.
[35] Cfr. Pio XII, Discorso al IX Congresso della Società Italiana di Anestesiologia, 24 febbraio 1957.
[36] Cfr. R. Jaccard – M. Thévoz, Manifesto per una morte dolce, EdT, Torino 1993, p. 24.
[37] M. Reichlin, L’etica e la buona morte, Edizioni di Comunità, Torino 2002, p. 94.
[38] Ivi, p. 92.
[39] P. Donatelli, “Dottrina del doppio effetto”, in E. Lecaldano (ed.), Dizionario di Bioetica, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 102-104.
[40] Ma, aggiungiamo, anche della sua morte, che avrebbe potuto evitare con l’accanimento terapeutico.
[41] Certamente sedare il dolore e conservare la vita sono entrambi scopi buoni. Ma possono esserci situazioni in cui entrano in contrasto e in cui non è possibile promuovere entrambi. Qui bisogna compiere un’azione che mentre consente di raggiungere uno dei due scopi, manca inevitabilmente l’altro. Il beneficio, insomma, viene ottenuto solo a prezzo di un danno. Il problema, in questi casi, non è dunque di decidere se causare o non causare il danno, ma di capire se il beneficio può ragionevolmente compensare il danno. In questo caso, proprio perché il danno è comunque inevitabile, noi siamo moralmente responsabili del beneficio che abbiamo scelto di promuovere e non del danno che, in questo modo, abbiamo non già causato, perché questo si sarebbe comunque verificato, ma solo tollerato che rimanesse collegato alla nostra azione di beneficio.
[42] Cfr. H. Kuhse, The Sanctity of Life Doctrine in Medicine. A Critique, Clarendon Press Oxford 1987, p. 119. Così, per esempio, il celebre dottor Jack Kevorkian, più volte rinviato a giudizio negli Stati Uniti per aver aiutato alcuni malati a suicidarsi, spiegò di averlo fatto nell’intento di porre fine alle loro sofferenze e non per causarne la morte. Cfr. P. Singer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più, Il Saggiatore, Milano 2000, p. 144.
[43] Società Italiana di Cure Palliative, Raccomandazioni sulla Sedazione Terminale/Palliativa, Ottobre 2007, su https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2017/01/Sedazione-Terminale-Sedazione-Palliativa.pdf . Si vedano, sul tema, G. Miccinesi – J. Raho, Morire senza coscienza. La giustificazione morale della sedazione palliative profonda continua, “Medicina e Morale”, 68 (2019), 4, pp. 397-410; S. Cacace, La sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte: le sette inquietudini del diritto, “Rivista Italiana di Medicina Legale”, 2 (2017) e F.G. Pizzetti, “Ai confini delle cure”: la sedazione palliativa (o terminale) tra diritto di non soffrire e diritto di morire, in P. Macchia (a cura di), Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento biologico. Profili clinici, giuridici, etici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 135-174
[44] L. Radbruch – C. Leget – P. Bahr – C. Müller-Busch – J. Ellershaw – F. de Conno Vanden Berghe, Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care, “Palliative Medicine”, 2015, Nov 19.
[45] N. Sykes, A. Thorns, The use of opioids and sedatives at the end of life, “Lancet Oncology”, 2003, May, 4 (5), 312-318 e E.M. Beller et al., Palliative pharmacological sedation for terminally ill adults, “Cochrane Detabase Syst Rev.”, 2015, Jan 2, p. 1.
[46] Comitato Nazionale per la Bioetica, Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte, 29 gennaio 2016, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2016.
[47] Società Italiana di Cure Palliative, Raccomandazioni della SICP sulla sedazione terminale/sedazione palliativa (2007), cit.
[48] Cfr. J. Finnis, A philosophical case against euthanasia, in J. Keown (a cura di), Euthanasia Examined: Ethical, Clinical, and Legal Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 22-35.
[49] F. G. Pizzetti, Ai confini delle cure: la sedazione palliativa (o terminale) tra diritto di non soffrire e diritto di morire, in P. Macchia (a cura di), Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento biologico Profili clinici, giuridici, etici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 135-174.