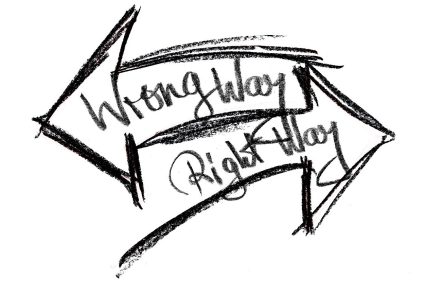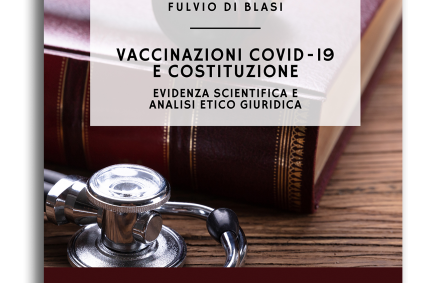di Robert Spaemann
QdB – Questioni di Bioetica 1/2009
* Il breve testo che qui presentiamo in prima traduzione italiana è stato scritto da Robert Spaemann per il Deutsche Zeitschrift für Philosophie, che nel 2002 (a. 50, n. 1) ha ospitato un “Symposium” sul controverso libro di Jürgen Habermas Il futuro della natura umana (il contributo di Spaemann, dal titolo “Habermas über Bioethik”, sta alle pp. 105-109). Al “Symposium”, oltre a Spaemann, hanno partecipato con loro contributi originali anche Ludwig Siep (“Moral und Gattungsethik”, ivi, pp. 111-120) e Dieter Birnbacher (“Habermas’ ehrgeiziges Beweisziel – erreicht oder verfehlt?”, ivi, pp. 121-126). Spaemann, Siep e Birnbacher leggevano il testo di Habermas nella prima edizione (Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2001). Non conoscevano, pertanto, il “Postskriptum” pubblicato da Habermas nel 2002, e che si trova come prima “Appendice” alla traduzione italiana (Poscritto, in Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002, pp. 77-98). In esso, viceversa, Habermas risponde, tra l’altro, proprio ai rilievi mossegli nei contributi di questo “Symposium ” del Deutsche Zeitschrift – in verità, quasi solo a Siep, dedicando espressamente a Spaemann appena un rigo. In ogni caso, il pubblico italiano è stato già messo in condizione di conoscere i termini di questo dibattito, per lo meno presentati dal punto di vista di Habermas: v. il numero monografico di Humanitas su La sfida dell’eugenetica. Scienza, filosofia, religione (n. 4/2004) ed ivi, in particolare, i contributi di Paolo Costa (“Che cosa significa «moralizzare la natura umana»? Una nota su Il futuro della natura umana di Jürgen Habermas”, pp. 737-743) e di Omar Brino (“Bioetica e «Metafisica». Il dibattito tra Habermas, Siep e Spaemann in merito a Il futuro della natura umana”, pp. 744-751), nonché, per una valutazione critica di segno opposto, C. A. Viano, “Antiche ragioni per nuove paure: Habermas e la genetica”, Rivista di Filosofia, 2/2004, pp. 277-296, e D. Birnbacher-J. E. Lunshof, “Riguardo ad alcuni argomenti contro la selezione della prole”, Bioetica. Rivista interdisciplinare, 4/2004, pp. 634 ss.
Rispetto a molti degli appartenenti alla sua scuola, fa onore ad Habermas che la sua coscienza dei problemi non si limiti a quelle domande alle quali è sin dall’inizio assicurata e consolidata una risposta trascendentalpragmatica. In relazione alla pretesa dell’etica del discorso di ricostruire senza ammanchi la filosofia morale di Kant, tuttavia, due questioni sono apparse fino ad ora come un punto cieco su cui fare luce. Anzitutto la domanda circa chi, e sulla base di quali caratteristiche, appartenga a quella comunità i cui membri devono rendere conto gli uni agli altri delle loro azioni e omissioni, nella misura in cui esse riguardano altri. A voler rispondere a questa domanda secondo l’etica del discorso, sembra di andare a finire in un circolo, e per questo mi sono sempre espresso nel senso di un divieto di dare una definizione dell’uomo: o ciascun esemplare del genere homo sapiens entra in questa comunità non per via di cooptazione, ma come membro nativo a prescindere dalla prova di qualsiasi qualità, o altrimenti il concetto di un “diritto dell’uomo” dev’essere in generale eliminato dalle nostre costituzioni e rimpiazzato con quello di “diritti della persona”1. La seconda domanda è quella circa la relazione tra ciò che Habermas chiama morale e ciò che egli chiama etica, ovvero tra il giusto e il bene. La riduzione della rappresentazione della vita buona ad un affare privato, e la sovraordinazione di un universalismo del metodo di produzione consensuale delle regole, indifferente rispetto a queste rappresentazioni, presenta una difficoltà: su queste basi non si può rispondere alla domanda «why to be moral?»2 Hobbes, il padre di quest’idea, aveva una risposta: è la paura di una morte violenta precoce di ciò che ci porta alla ragione. Ma cos’è ciò con cui, nei cui confronti, questa paura non ha alcuna forza di motivazione? Hobbes volle ad ogni costo reprimere una religione che, con un motivo concorrente più forte, privasse della loro forza la paura della morte e la volontà di pace. L’argomento trascendental-pragmatico dell’incoerenza dei comportamenti parassitari è debole. La pretesa di coerenza è già essa stessa qualcosa di morale. E la disponibilità al discorso presuppone già una rappresentazione della vita buona, alla quale la giustizia e la pace appartengono – tra l’altro, e forse neanche in primo luogo. Il bene è per definitionem ciò che noi non possiamo [können] fare a meno di volere. Il giusto, abbiamo il dovere [sollen] di volerlo. Ma ciò che noi abbiamo il dovere di volere, deve poter esser parte della nostra vita buona, oppure noi possiamo non volerlo, a meno che non modifichiamo ciò che ci appare come il bene3.
Nel suo nuovo piccolo libro Habermas si pone, sia pure con impegno disuguale, entrambe queste domande. Se le pone per dare un contributo al dibattito bioetico attuale e nella convinzione che un tale contributo è possibile solo se la natura dell’uomo, che soggiace a tutti i discorsi senza essere fondata riflessivamente [im Unvordenklichen gründende], viene come tale espressamente pensata quale condizione di ogni discorso, e se le forme di vita sono considerate non più come adiaphora morali, ma dal punto di vista del vero e del falso. Si dice ora: «Perché la filosofia dovrebbe indietreggiare di fronte a ciò di cui la psicoanalisi, per esempio, si ritiene capace?». Sotto la pressione della oggettivazione scientista dell’uomo ormai divenuta definitiva nella pratica, Habermas vede la sua collocazione tra i “vecchi europei”, sia pure sempre con qualche riserva, e si decide per un concetto di filosofia che non si limita ad una meta-posizione formale, ma che già pregiudica i propri contenuti e non rinnega la propria vicinanza alla religione4. Richiamandosi alle nostre intuizioni, parole come “oscenità” e “disgusto”5 fanno naturalmente appello ad un’intesa non mediata discorsivamente, e devono rinunciare al consenso di coloro che non condividono queste intuizioni, e che secondo Aristotele non meritano argomenti, ma rimproveri. Nella «prospettiva di partecipazione predeterminata» della filosofia – a differenza della sociologia – Habermas si era riconosciuto già prima, da ultimo in un saggio del 1999.
Questo non vuol dire che Habermas non argomenti. Lo fa anche qui, sempre con accuratezza. Il piano argomentativo è, tanto prima quanto ora6, quello trascendental-pragmatico, ed anche nell’ambito della predisposizione delle decisioni politiche non potrebbe essere un altro (il “morale” per Habermas riducendosi, in un’ipotesi ideale, a ciò che è giuridicamente coercibile). Io trovo nel libretto una serie di argomenti noti, che sono anche miei, sia contro la programmazione del genoma sia contro la ricerca che comporti la distruzione di embrioni. Contro la manipolazione genetica egli dice prima di tutto che la spontaneità [Selbstverständlichkeit] libera da costrizioni dei rapporti tra tutti i membri della famiglia umana sulla base di una fondamentale uguaglianza è minacciata, nel momento in cui essi vengono non generati [gezeugt], ma “prodotti” [gemacht], uno dall’altro. La proposta di Sloterdijk, di rimpiazzare un’educazione divenuta frattanto relativamente ineffettiva con la programmazione genetica7, misconosce che l’educazione è una forma di trasmissione di forme di vita culturali, dalla quale noi possiamo sempre di nuovo emanciparci, laddove ogni ribellione contro la nostra natura rimane velleitaria [ohnmächtig]. L’impotenza nei confronti della natura, peraltro, non tocca il nostro status personale tanto quanto l’impotenza contro i programmi di qualcun altro che ci stia di fronte come nostro produttore [Macher]. Habermas vuole che siano considerati validi solo quegli interventi rispetto ai quali siamo giustificati a presupporre il consenso dei manipolati. Tali sono gli interventi terapeutici – sulla base di un concetto di salute restrittivo (in ogni caso, non del tipo di quello dell’OMS). Il recensore tuttavia trasale, quando egli annovera tra gli interventi di questo tipo anche quelli che hanno per scopo un generale allungamento della vita. La nostra aspettativa di vita media, geneticamente condizionata e non abbreviata da ritardi di civiltà, dovrebbe essere intesa come malattia tanto quanto la capacità delle donne di rimanere incinte attraverso la copula. Se noi non accettiamo qui come dato alcun limite naturale della vita geneticamente condizionato, ogni ulteriore limite rimarrà arbitrario. Sotto l’aspetto dell’etica di genere, invecchiamo comunque già troppo. Naturalmente, fa parte della vita che si vivrebbe volentieri ancora un po’ di più, fin tanto che ci va bene. Ma non sarebbe altrimenti se, a 130 anni, fossimo ancora in buona salute. Sotto l’aspetto del consenso successivo dell’interessato, ci sarebbe tra l’altro da ripensare anche la produzione di uomini in vitro. Laddove gli uomini non nascono naturalmente8 come conseguenze di relazioni sessuali, ma sono prodotti [von Hand gemacht] intenzionalmente, i produttori diventano responsabili per l’esistenza di coloro che vengono dopo di loro. Ma nessuno può soddisfare a questo dovere di render conto. Che «rimanga notevolmente astratto» che qualcuno possa rinfacciare la propria esistenza a coloro ai quali la deve, quest’opinione di Habermas è sicuramente troppo ottimistica, come alcune pronunce giudiziali europee mostrano9. E una volta che la diagnostica prenatale con la scopo della selezione è una prassi stabilita, allora diviene una scelta discrezionale quella di mettere la propria esistenza in conto ai genitori come una causa di danno. Per ciò che riguarda il rapporto con gli embrioni umani, qui Habermas si muove su campi meno sicuri. Il suo approccio di filosofia sociale lo conduce da un lato a trattare la personalità come risultato di un «atto socialmente individualizzante di accettazione nel pubblico nesso di interazione di un mondo-di-vita intersoggettivamente condiviso»10. È con la nascita che l’uomo diventa “seconda persona” per altri uomini. Dall’altro lato, l’uomo prima della sua nascita non è meramente una cosa. La relazione con lui «tocca la nostra autocomprensione come essere di genere [Gattungswesen]». «Le nostre opinioni su – e il nostro rapporto con – la vita umana prepersonale costruiscono per così dire un ambiente stabilizzante di un’etica di genere per la morale razionale del soggetto dei diritti umani – un contesto d’ambientamento, che non può essere eroso, se la morale stessa non deve restare senza fondamenti»11. Significativamente Habermas mette in parallelo la relazione con gli uomini non ancora nati e la relazione con gli uomini dopo la loro morte. Questo, probabilmente, lo avvertirà come controintuitivo ogni madre che sente scalciare il suo bambino non ancora nato. L’argomento di Habermas ricorda l’argomento di Kant contro la tortura sugli animali, che si trova anche negli antichi catechismi: essa è riprovevole, perché abbrutisce e così danneggia indirettamente ogni uomo, che diventa vittima dell’abbrutimento delle torture sugli animali. Questo è chiaramente corretto, ma allora si pone il quesito, perché un’attività in sé innocente ed innocua abbia un tale effetto su chi la compie. Non dovrebbe forse una tale attività essere qualcosa di malvagio in se stessa?
E se la relazione con i non ancora nati è in sé un adiaphoron, perché i non ancora nati non godono di alcuno status di persona, che significato dobbiamo dare all’indiscutibile continuum sociale e psicologico? Questo continuum esprime certamente la maniera in cui noi stessi comprendiamo la nostra identità, cioè come quella di una forma di vita naturale. Noi diciamo «io sono stato generato così e così», «mia madre mi voleva abortire», e così via. Quel che Habermas chiama metafisica, io [lo considero] nient’altro che il prendere sul serio un fenomeno, il prendere sul serio la maniera in cui noi facciamo esperienza di noi stessi. Il concetto sociopsicologico di “identità”, che oggi determina in ampia misura il discorso teoretico pubblico, è e rimane un concetto secondario, che allude solo ad un fascio di proprietà rilevanti per l’autocomprensione, cioè a come io sono. Chi sia io12, a questo si risponde obiettivamente, tanto prima quanto ora, a partire dal registro degli status personali, e l’identità di ciò che in esso si chiama individuo è quella di un organismo umano, che è cominciato ad esistere con la fusione di una cellula uovo con uno spermatozoo. Habermas vuole fissare la nascita come ingresso nella comunità personale di riconoscimento. Ma allora i prematuri sarebbero in una condizione privilegiata nei confronti dei bambini che restano nel seno materno ancora altri due mesi. Habermas non fa alcun tentativo di difendere questo criterio della nascita nei confronti di coloro che, per esempio, fissano il terzo mese [di gravidanza] o, all’opposto, il compimento del secondo anno di vita quale inizio dell’essere personale, come ad esempio Peter Singer. Poiché neanche un neonato mostra quelle caratteristiche sul cui fondamento noi parliamo degli uomini come di persone. Se non basta che egli appartenga al genere i cui membri adulti, di regola, presentano queste caratteristiche, allora potremmo non assegnare neanche a lui uno status personale. La risposta di Habermas a Singer sarebbe più o meno questa: Singer tratta la personalità come una proprietà soggettiva correlata a determinati esseri viventi, mentre è questione essenzialmente di status all’interno di una relazione di riconoscimento e interazione. E questa relazione comincia con la nascita. A me sembra che la verità stia al di là di entrambe le posizioni, anche se più vicino a quella di Habermas. Anzitutto il rapporto di interazione comincia molto prima della nascita. Comincia con l’attimo in cui si accerta la gravidanza. Che all’inizio sia una relazione completamente e del tutto asimmetrica, non è un contro-argomento. La relazione è asimmetrica – in misura decrescente – fino all’adolescenza, anzi a rigore per tutta la vita. La relazione di genitori e figli non è reversibile. Ma in secondo luogo, il pensiero di un’accettazione in una comunità di riconoscimento che abbia il carattere di una cooptazione contraddice il concetto del riconoscimento come persona. Noi sperimentiamo questo riconoscimento come dovuto, come risposta a un appello incondizionato che ci viene dall’altro, e che per esempio Lévinas ha descritto con parole persuasive. E Lévinas mette la teoria etica, che tematizza questa pretesa, sullo stesso piano della metafisica. La continua insistenza di Habermas sulla fine della metafisica ha sempre il carattere di un’assicurazione su cui si giura, [ma] che non è mai conseguita argomentativamente. Così è chiaro: il solipsismo non è compatibile con alcuna morale o etica, se esso è più che una costruzione di metodo. La decisione contro il solipsismo però è e rimane una decisione metafisica. Essa è la decisione metafisica.
Se Hume ha ragione con questa frase: «We never do one step beyond ourselves», allora la filosofia può essere solo una descrizione del sentimento etico, che deve rinunciare alla prospettiva della condivisione. Ma perché dev’essere ammesso a priori che Whitehead è sorpassato da Hume? Whitehead conobbe gli argomenti di Hume, e credette di averne di migliori. Le parole “metafisico”, “postmetafisico” e “sotto le condizioni della modernità” dovrebbero forse per un attimo essere tratte fuori circolazione, se si vuole la chiarezza dell’argomentazione tra filosofi. Certo, dopo Nietzsche metafisica e ontologia non possono più avere le stesse sembianze di prima13. La metafisica deve riflettere il suo proprio status all’interno dei nostri tentativi di comprensione. Il rapporto di fondazione tra ontologia ed etica diventa perciò inevitabilmente circolare. «L’essere non è un predicato reale», scrive Kant. L’essere nel senso dell’esistenza non è empiricamente dato e la sua affermazione non è mai stringente. Io posso rifiutarmi di riconoscere dietro l’atteggiamento di dolore di un uomo e ancora di più di un animale un vero dolore, posso rifiutarmi di riconoscere il vivente come vivente. L’affermazione dell’essere, cioè la metafisica, è sempre un atto di libertà, non diversamente dall’affermazione di una conclusione da premesse evidenti: è facile finire per rifiutarsi di affermare B [pur] dopo aver affermato A. E se veramente, come Habermas scrive nel saggio cui si è fatto cenno sopra, il passo da una regola riconosciuta come razionale alla decisione personale di seguire io stesso questa regola, dopo il tramonto della fede in Dio, non può più essere reso razionalmente plausibile, allora forse è più razionale esaminare nuovamente gli argomenti a favore dell’esistenza di Dio. Ci si trova con ciò, tanto prima quanto ora, in ottima compagnia, e la diffusione di questa convinzione è sempre ancora più grande di qualunque dei sistemi morali esistenti. La metafisica non deve poggiare sulla pretesa di sapere più di chiunque altro. «Essentiae rerum nobis sunt ignotae», scrive uno dei grandi metafisici, Tommaso d’Aquino. Ciò che egli come metafisico credeva di capire, era ciò che tutti intendono quando prendono qualcosa per “vero”.
Per ciò che riguarda poi lo status personale del non nato, non si esige, per accordarglielo, nessuna ammissione metafisica ulteriore rispetto a quelle che sono necessarie per accordare lo status personale a chiunque. L’argomento decisivo l’ha già esposto Kant. È, se si vuole, un argomento trascendental-pragmatico su una base scettica ovvero agnostica. Dopo che Kant ha chiarito – e Habermas lo segue in questo – che la «natura razionale esiste come scopo in se stessa», egli scrive: «Siccome il generato è una persona ed è impossibile farsi un concetto della generazione di un essere dotato di libertà mediante un’operazione fisica, allora dal punto di vista pratico è un’idea completamente corretta ed anche necessaria quella di considerare l’atto della generazione come tale che per mezzo di esso noi abbiamo posto una persona nel mondo». Dopo che Habermas ha compiuto il passo di prendere in considerazione qualcosa come una “natura umana”, talché solo nei confronti di essa si concretizza il rispetto verso l’uomo in quanto persona, sarebbe ovvio che seguisse anche questo passo di Kant. Ma, come si è detto, anche una conclusione plausibile la si deve voler trarre.
(traduzione dal tedesco di Giovanni Magrì)
1) Sul rapporto tra i termini “uomo”, “individuo” e “persona” nella prospettiva di Spaemann è ovvio il rimando a Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” und “jemand”, Klett-Cotta, Stuttgart 1996, 19982; trad. it. Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Laterza,Roma-Bari 2005. Sul tema specifico dei diritti dell’uomo come diritti della persona è ancora ricco di suggestioni R. SPAEMANN, “Über den Begriff der Menschenwürde”, in E.-W. BÖCKENFÖRDE – R. SPAEMANN (hggb.), Menschenrechte und Menschenwürde, Klett-Cotta, Stuttgart 1987, pp. 295-313.
2) Se alla prima questione Spaemann ha risposto più ampiamente in Personen, per questa seconda domanda si può rinviare a Glück und Wohlwollen: Versuch über Ethik, Klett-Cotta, Stuttgart 1989, trad. it. Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano 1998.
3) Può essere utile richiamare l’attenzione allo sfasamento di piani tra i verbi che Spaemann utilizza in questo complicato passaggio. Com’è noto, infatti, sollen indica la modalità deontica dell’obbligo, a cui si contrapporrebbe (per indicare che si ha una facoltà, ovvero che ci si trova nella modalità deontica del permesso) il verbo dürfen. Viceversa, können non indica una modalità deontica, ma una possibilità ontica ovvero una capacità materiale o tecnica, e gli si contrapporrebbe (ad indicare propriamente la categoria ontologicamente correlata a quella di possibilità, cioè la necessità) il verbo müssen. Giustapponendo sollen a können, allora, Spaemann richiama il problema del rapporto tra l’ontico e il deontico (tra il Sein e il Sollen, per citare direttamente, ad esempio, Hans Kelsen, e, a monte, le traduzioni tedesche correnti di Hume) come problema teoretico presupposto alla distinzione, ed eventualmente alla separazione, tra il bene (das Gute) e il giusto (das Gerechte).
4) Si tratta dello stesso concetto di filosofia per il quale un altro pensatore proveniente dai ranghi della sociologia, Niklas Luhmann, ha coniato l’aggettivo di “vetero-europea”: v. “Laudatio von Robert Spaemann. Niklas Luhmanns Herausforderung der Philosophie”, in N. LUHMANN, Paradigm Lost. Über die Ethische Reflexion der Moral, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1990; trad. it. R. SPAEMANN, “La sfida di Luhmann alla filosofia”, in N. LUHMANN, Il paradigma perduto, Meltemi, Roma 2005, pp. 61-69, passim).
5) Nel testo di Habermas, in effetti, “Obszönitat” e “Abscheu” (e termini analoghi) ricorrono più di una volta. Ad esempio, laddove Habermas riporta la notizia del «nuovo regolamento delle onoranze funebri nella città di Brema», che prescrive che anche i feti (si tratta di «parti prematuri, nati morti e interruzioni cliniche di gravidanza») non siano più «semplicemente eliminati come rifiuti etici (così li definiva il linguaggio della burocrazia) bensì sepolti in cimitero con anonime fosse comuni»; commenta Habermas: «già la reazione che il lettore prova di fronte all’espressione oscena [corsivo mio] – per tacere naturalmente della prassi penosa ch’essa designava – tradisce, nella controluce dell’embrione morto, la diffusa e profonda soggezione da noi provata di fronte all’integrità della vita umana prenatale, vita che nessuna società civilizzata può permettersi di offendere» (trad. it. cit., p. 38). V. anche pp. 41 s.: «Non so se interpreto correttamente le discussioni sull’uso sperimentale degli embrioni o sulla generazione “con riserva” degli embrioni stessi, ma mi pare che le reazioni emotive esprimano non tanto una indignazione morale, quanto una sorta di ripugnanza di fronte a qualcosa di osceno […]. Sintomatico è il disgusto alla vista delle creature chimeriche che nascono dalla violazione genetica dei confini tra le specie»; p. 70: «Più complicato è spiegarci come mai proviamo ripugnanza all’idea che l’uso sperimentale degli embrioni strumentalizzi la vita umana alle aspettative – di profitto non meno che di utilità – riferibili a un possibile progresso scientifico del futuro».
6) L’espressione tedesca, che ricorre altre due volte in questo breve testo, è “nach wie vor”, “dopo come prima”. Non si può non rinviare all’autocomprensione del proprio orizzonte speculativo, da parte di Habermas, come “pensiero post-metafisico” (“nach-metaphysisches Denken”: così anche il titolo di un importante libro di Habermas, del 1988; trad. it. Il pensiero postmetafisico, Laterza, Roma-Bari 1991) o anche “post-convenzionale”; nonché all’uso ricorrente del “nach” come cifra di un guadagno, o più spesso di una perdita, assunti come teoreticamente irreversibili, nella filosofia tedesca in generale e nell’orbita della Scuola di Francoforte in particolare (si pensi al “nach Auschwitz” già in Adorno, prima di Jonas). La risposta di Spaemann, in seguito meglio articolata, è già felicemente compendiata in questa formula: “nach wie vor”.
7) Spaemann si riferisce al controverso saggio di Peter Sloterdijk intitolato Regeln für den Meschenpark, e al dibattito che ne è seguito sulle colonne di Die Zeit (v. ora “Der Streit um den Menschen”, Zeit-Dokument, n. 2, 1999, pp. 3-61; in particolare, l’intervento di Sloterdijk è alle pp. 4-15.
8) Nel testo, naturwüchsig, che ha una sfumatura di significato differente da natürlich (su cui v. ovviamente R. SPAEMANN, Das Natürliche und das Vernünftige: Essays zur Antropologie, Piper, München und Zürich 1987, trad. it. Natura e ragione. Saggi di antropologia, EDUSC, Roma 2006), ma anche da selbstverständlich. Il traduttore italiano di Habermas, per esempio, rende “Bedingungen der Naturwüchsigkeit” con “requisiti di naturalità” e, nella stessa pagina, “Selbstverständlichkeit” con “senso di naturalezza” (cfr. Il futuro della natura umana, trad. it. cit., p. 44).
9) Spaemann allude qui alle pronunce sulla cd. Wrongful Birth che, avviate dalla sentenza della Corte d’appello della California sul caso Curlender del 1980, hanno avuto più di recente casi emblematici in diversi paesi europei: da una decisione della Corte di giustizia federale tedesca del 1986 al caso di Kelly Molenaar in Olanda, al più celebre di tutti, il cd. “affaire” Perruche in Francia. Per un inquadramento di sintesi cfr. S. AMATO, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo, Giappichelli, Torino 2006, specie pp. 122-124.
10) Così, testualmente, ne Il futuro della natura umana, trad. it. cit., p. 37.
11) Ibidem, p. 68 (trad. leggermente modificata).
12) Ho inteso rendere così la differenza tra “was für einer ich bin“ e “wer ich bin”. Propriamente, con “was für einer” si chiede di determinare la specie all’interno di un tipo: per esempio, “ho comprato una macchina nuova” (“Ich habe ein neues auto gekauft”), “quale?” (“was für eins?” – “ein Audi”).
13) Anche per Spaemann, dunque, sembra esserci un “nach” teoreticamente irreversibile. Però, a dover cambiare dopo Nietzsche non è né il contenuto, né la possibilità di principio dell’indagine metafisica: è, semmai, il suo significato epistemico in rapporto agli altri saperi e alle condizioni della libertà personale e della pubblicità del discorso. Per questo, Spaemann non dice che metafisica e ontologia non possono più “essere” le stesse, ma che non possono più “avere lo stesso aspetto” (“aussehen”).