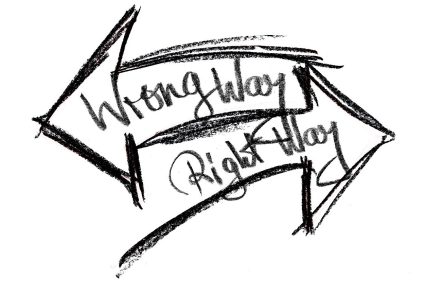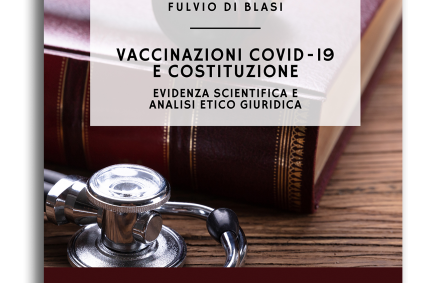Iacone Ignazio, Professore a contratto (bioetica ed etica delle imprese), Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa, Università LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima (Bari) iacone@lum.it, iaconeignazio@libero.it
QdB, 1/2023
La morte come fatto culturale
Oltre che evento naturale che accomuna i viventi, la morte è anche fatto culturale. Lo è in primis perché di essa viene data una lettura, un significato, direttamente dipendente dai valori, le credenze, la fede di un dato gruppo umano[1]. Lo è anche perché il suo prorompere viene “addomesticato” dall’uomo secondo riti che la precedono e la seguono, e che sono definiti culturalmente.
Le risposte che le diverse culture danno all’angoscia della morte, i sistemi che propongono per elaborarla, sono tanto vari che testimoniano già di per sé che non esiste un unico modo di pensare la morte, come non c’è un unico modo di pensare la vita[2].
Semioticamente, il diverso significato che si attribuisce al significante della morte fisica, è strettamente intrecciato con quello attribuito da una data cultura alla vita. Una euthanasia, letteralmente una «buona morte»[3], è intesa in modo differente a partire da quale sia considerata una buona vita, una vita pienamente degna di questo nome. Per questa ragione, tanto sincronicamente che diacronicamente, l’osservazione offerta dalla ricerca antropologica ci mostra modelli opposti, della buona vita e della buona morte.
I due solchi culturali maggiori sono rappresentati dalla lettura del mondo antico e del Cristianesimo, che riassumono le sole due prospettive sulla morte indagate dalla filosofia, e riassunte dal passaggio di Seneca «Mors quid est? Aut finis aut transitus»[4]. Nel mondo antico occidentale, mancando quasi sempre un orizzonte al di là della vita terrena (a parte quello stato di mezzo, senza beatitudine, che era l’Ade, o più genericamente gli inferi), tutto il valore dell’esistere era attribuito alla vita presente e fisica che aveva dunque il suo vero culmine, la sua dignità, nel tempo vigoroso della giovinezza. Per questo, come ricorda uno studioso di antropologia della morte, «“bella morte”, significò lo spegnersi nel pieno fiorire degli anni giovani e in un rapido ed immediato distacco dall’unica realtà, quella del mondo presente, da cui siamo circondati»[5].
Jean-Pierre Vernant nota che la bella morte nell’Iliade è quella che incarna i valori omerici, la morte degli aneres andres, cioè gli uomini nel pieno fiorire della virilità e della forza, la cui morte è bella (kalos thanatos) e la più desiderabile perché apre alla gloria, solo valore a cui ambire:
Pour ceux que l’Iliade appelle aneres (andres): les hommes dans la plénitude de leur nature virile, à la fois mâles et courageux, il est une façon de mourir au combat, dans la fleur de l’âge, qui confère au guerrier défunt, comme le ferait une initiation, cet ensemble de qualités, de prestiges, de valeurs, pour lesquels, tout au long de leur vie, l’élite des aristoi, des meilleurs, entrent en compétition. Cette «belle mort» (kalos thanatos) pour lui donner le nom dont la désignent les oraisons funèbres athéniennes, fait apparaître, à la façon d’un révélateur, sur la personne du guerrier tombé dans la bataille l’éminente qualité d’anêr agathos3 d’homme valeureux, d’homme de cœur. A celui qui a payé de sa vie son refus du déshonneur au combat, de la honteuse lâcheté, elle assure un indéfectible renom. La belle mort, c’est aussi bien la mort glorieuse (eukleês thanatos)[6].
Con il Cristianesimo, fatti salvi gli eccessi medioevali, il valore della vita terrena resta altissimo, ma è relativizzato dallo sguardo rivolto al destino eterno dell’anima, ragion per cui si comincia a desiderare di preparare la morte, e la bella morte non è più quella improvvisa, ma piuttosto quella che si prepara con una buona vita; di certo la morte non è più la temuta fine, ma un passaggio denso di speranza, sin dalle lettere di San Paolo che, tra le altre cose, scrive ai cristiani di Tessalonica: «Non vogliamo poi lasciarvi nell’ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui»[7].
È evidente che in ogni universo di riferimento che rifletta sulla fine della vita entra in gioco il rapporto dell’uomo con l’invisibile, con le realtà trascendenti: la fede di un popolo, le credenze mitico-religiose, persino le superstizioni contribuiscono a profilare un orizzonte per l’uomo che scompare dalla vista dei propri simili lasciando lo sgomento del lutto. La domanda che si incunea nel collocare la morte in queste coordinate è: chi è il padrone della vita? Chi decide di essa e della sua fine? Dalle Moire greche alla Morte personificata e divinizzata di numerose culture del sud del mondo, al Dio delle fedi monoteistiche, nelle culture umane si è cercata una risposta non solo al «perché» si muore, ma anche al «per chi», e com’è facile intuire da questo tema passa la definizione non tanto di chi concretamente toglie la vita, ma di chi ha il diritto di toglierla, a seconda del fine ultimo, dell’orizzonte di un dopo-morte che è talvolta immaginato dall’uomo, talvolta – come per il Cristianesimo – è rivelato. La fede cristiana ha dato valore, anzi ha dato senso alla morte iscrivendola in quella redentrice di Cristo, «primizia di quelli che sono morti»[8], e ha ricostruito l’ideale di buona morte come passaggio critico e significativo, una parte della vita da accompagnare e attraversare in una dimensione spirituale. Accanto a questa rivalutazione, la fede della Chiesa ha ribadito il valore assoluto della vita umana, indipendente da qualunque condizione[9]. Numerosi filosofi di ogni tempo si sono dedicati a ragionare della morte per cercare un senso della vita, e viceversa, approdando alle più diverse teorie: Kirkegaard guarda alla morte come unica possibilità di superamento dell’angoscia insita nelle possibilità dell’esistere, e via d’approccio al divino[10]. Al contrario Heidegger vede nella morte la fine dell’essere, ma al tempo stesso lo stimolo costante a vivere in modo autentico, proprio perché consci che la vita non è che naufragio[11].
Sul filone esistenzialista, ma distante dalla visione heideggeriana, Sartre elabora una filosofia che, in estrema sintesi, guarda alla morte non come una cessazione ontologica, come un non-essere, ma come un cambiamento, dall’essere per-sé che vede l’uomo nel presente, all’essere in-sé che mette fine alla sua progettualità, lasciandolo in balìa degli altri e del loro pensiero su di lui[12].
L’approccio alla morte, come quello alla vita, è fortunatamente sempre urgente nell’uomo e nei sistemi culturali, scientifici o di fede, che su di esse si interrogano, e non è risolto il tema se la vita sia sempre degna di essere vissuta, oppure questa dignità dipenda da fatti contingenti.
Nelle sue estreme conseguenze, non senza cadere in numerose contraddizioni, il pensiero di Peter Singer propone una lettura del tutto relativa della dignità della vita, arrivando a postulare che ci sono esseri umani che non sono persone per via delle loro condizioni, e ci sono animali che persone lo sono, in quanto dotati di una dignità superiore a quella di certi umani privati, per le loro particolari condizioni, di certe caratteristiche come l’autocoscienza o il «voler continuare a vivere o avere progetti per il futuro»[13]: caratteristiche che si trovano in certi animali, ma non si trovano in talune persone. Da questo discenderebbe l’attribuzione del diritto alla vita solo a coloro che si possono definire persone a pieno titolo. Scrive il discusso bioeticista australiano: «Uno scimpanzé, un cane o un maiale, per esempio, hanno un più alto grado di autocoscienza e una maggiore capacità di relazioni significative con gli altri di un neonato gravemente ritardato o di una persona in stato di avanzata senilità».
È una visione strettamente utilitaristica, mirante a rivoluzionare la bioetica sulla base del rifiuto di qualunque valore intrinseco della vita umana, nella convinzione che tale valore etico assoluto discenda esclusivamente dal pensiero religioso, del quale è auspicabile liberarsi. Un simile approccio apre com’è ovvio all’accettazione dell’eutanasia, sia come scelta di lasciar morire sia di uccidere un individuo gravemente sofferente, e accanto a essa del suicidio assistito se richiesto dal paziente.
Il diritto a morire non fa, nel pensiero di Singer, differenze di specie (umana o animale) ma distingue l’individuo per le caratteristiche che ha in quel momento «per esempio, al suo desiderio di continuare a vivere o al genere di vita che è capace di condurre»[14].
Si tratta di tesi capaci di scandalizzare nei loro portati più estremi, come a proposito della selezione dei bambini, ma in realtà una visione utilitaristica sottende molta parte del pensiero etico odierno sul fine vita, sebbene con toni certamente meno provocatori. Un utilitarismo talvolta ben celato, forse addirittura non del tutto cosciente in taluni sostenitori del «diritto di morire», che paradossalmente non si accompagna a un altrettanto assoluta difesa del «diritto di vivere».
Di fatto questi approcci, frutti delle filosofie dell’immanenza, dell’individualismo, trasformano la morte da evento a realtà estranea, che non ci riguarda, per il fatto che essa trasforma gli uomini in «cose»[15].
Eutanasia nella storia
Un dibattito etico sul fine vita e sull’eutanasia è in qualche misura sempre esistito nella storia, dividendo in ogni epoca i fautori di un diritto a darsi la morte da coloro che non lo ammettevano.
Tra questi ultimi lo stesso Ippocrate, che dà nome al giuramento recitato da chi diventa medico, che nella sua forma classica recitava:
Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un’iniziativa del genere; e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l’aborto.
Il mondo occidentale antico, pur considerando generalmente ignominioso il darsi la morte, conobbe diverse fasi e sfumature sull’argomento: oltre alla ben nota eutanasia dei neonati a Sparta, i greci rifiutarono il più delle volte il suicidio, ma Platone nelle sue Leggi prescrive una sepoltura ignominiosa solo per chi si dà la morte in assenza di condizioni giustificative, come per gli adulti gravemente ammalati, che potevano venire soppressi con la collaborazione dei medici[16]. Socrate va incontro alla morte senza paura perché non si può temere quanto non si conosce, ma Platone nel suo Fedone ci narra la sua conversione al momento di bere la cicuta, riconoscendo l’immortalità dell’anima e fissando nella storia della filosofia un ideale di uomo saggio e fermo davanti alla morte in nome della verità. La filosofia stoica nel suo complesso esaltò le personalità che avevano scelto il suicidio come Epitteto[17], Catone il Giovane[18] e Seneca. Nel mondo romano in molti furono favorevoli alla scelta di porre liberamente fine alla propria vita, tra essi Tacito che elogia il suicidio di Petronio[19]; al contrario Augusto definì il suo ideale di morte nel trapassare felici e con onore: «Ebbe dunque una fine agevole, quale si era sempre augurato. Infatti, di solito quando sentiva che qualcuno era morto senza alcuna sofferenza, augurava per sé e per i suoi una simile εὐθανασίαν (proprio questa parola adoperava)»[20].
Anche molte culture del nostro tempo hanno praticato forme di eutanasia volontaria o involontaria, che hanno spesso al fondo forme di utilitarismo come l’impossibilità di farsi carico degli anziani non più produttivi o dei malati divenuti un peso; un esempio nel sud dell’India, dove è tuttora vigente un simile uso sugli anziani; un uso che suscita incredibilmente lo scandalo di un occidente che, dall’altra parte, promuove come progresso l’eutanasia di legge, dimenticando che la valutazione di quale vita sia degna è culturale e se, presso le nostre latitudini, si attribuisce questa condizione al sofferente inguaribile, in altri luoghi del mondo riguarda anche i sani giunti a un’età avanzata per la quale stanno diventando un peso per la famiglia[21]. È forse un residuo di eurocentrismo, quello che spinge a credere che solo le nostre motivazioni di togliere una vita siano valide e rispettabili fino a diventare legge, mentre quelle degli altri popoli sono barbare e da estirpare?
Che fine ha fatto la morte?
Negli anni ’50 l’antropologo inglese Geoffrey Gorer pubblicò un articolo dal titolo La pornografia della morte, nel quale proponeva una lettura del mondo moderno in cui al tabù del sesso era subentrato un nuovo tabù: quello della morte. Relegata nel privato, legata al divieto di piangere o almeno all’obbligo di contenersi, innominabile, impensabile, la morte secondo l’autore era stata «buttata fuori» dalla vita. Se prima di allora essa era un fenomeno naturale, a cui era frequente assistere anche da bambini, nel XX secolo essa è diventata sempre più oscena e vergognosa, qualcosa da nascondere e quasi negare ma al tempo stesso spettacolarizzare proprio in quanto oscena[22].
Questo rifiuto della morte, questa vergogna, è forse uno degli elementi che permeano la moderna idea occidentale di buona morte, a partire proprio dalla mancata accettazione di essa come fenomeno naturale e abituale, e dalla sua collocazione come caos inutile che irrompe in una vita dalla durata prolungata e ne scombina le carte, facendo sentire l’uomo in balia di altro da sé; minacciando, in definitiva, la sua signoria sulla propria vita. Similmente è considerato inutile il dolore, la paura del quale ci accomuna tutti, ma che per un certo modo di pensare di stampo utilitaristico non serve a nulla e toglie dignità a colui che lo sperimenta. La sintesi è che una vita sofferente, una vita non pienamente sana, non è degna di essere vissuta, e che lo spettro della morte può essere «addomesticato» anticipandolo, decidendone in autonomia tempi e modi, riappropriandosi di un evento che si apre, per chi non spera oltre esso, sulla voragine del non essere. È questa vertigine che più di ogni altra cosa si vuole esorcizzare, laddove non esiste prospettiva spirituale.
Questo rappresenta uno dei sostrati culturali dell’attuale dibattito, specialmente occidentale, sul fine vita. Vi si aggiunga una quasi totale assenza di dimestichezza con la morte e con il dolore, che sono relegati in strutture apposite, per lo più celati agli occhi e con cui dunque non si ha alcuna familiarità, contrariamente al passato quando gli operatori del lutto erano i familiari stessi, quando i giovani avevano modo di assistere alle fasi finali della vita e i bambini non venivano tenuti lontani dai cimiteri.
Resta il fatto che dolore e morte sono parte dell’esistenza, e non le si può realmente escludere. Di fronte a essi l’uomo è costretto a cercare un senso e dare una risposta che verte sul valore relativo o assoluto della vita. La Chiesa ha ribadito in varie sedi la difesa assoluta della vita umana in ogni momento e condizione. Ma le posizioni restano contrastanti, poiché vertono sul valore o disvalore attribuito al dolore e alla morte, e quindi sul giudizio etico relativo all’eutanasia, intesa come un gesto volto a porre fine alla sofferenza di un malato terminale o afflitto da una malattia talmente grave e priva di cure significative che rende insopportabile la sua vita. Tale intervento, sia esso passivo nel senso di omettere le cure che potrebbero tenere in vita il malato, sia attivo nel caso in cui si somministri una sostanza potenzialmente letale per caratteristiche o dosi (anche la terapia antalgica può avere come conseguenza il decesso) è definito dai suoi sostenitori un gesto di pietà umana, e certamente si radica in un nobile sentimento umano: la difficoltà di vedere un proprio simile soffrire. Tuttavia, la risposta a questa umanissima difficoltà non sta in quella che il Comitato nazionale per la bioetica ha definito «il mezzo più rozzo, più egoistico per venire incontro a esigenze che, anziché soffocate dalla morte, potrebbero ben altrimenti essere soddisfatte»[23].
C’è comune accordo sulla condanna a un atteggiamento di attaccamento alla vita che si configuri come accanimento terapeutico, quando le cure siano sproporzionate e addirittura aumentino le sofferenze del malato, ed è con l’intenzione di evitarlo che si parla sempre più spesso di «testamento biologico» o disposizioni sul fine vita, andando incontro a una serie di difficoltà e rischi, primo fra tutti il fatto che nella prassi medica non è semplice identificare cosa sia accanimento, e occorre «grande competenza professionale, senso della misura e un indispensabile ambiente di serenità»[24]. In effetti, la redazione di un documento contenente volontà relative a situazioni solo ipotetiche e lontane nel tempo e nella percezione vissuta, rende difficile determinare quali condizioni ricadranno sotto quelle volontà e quali no (si pensi anche solo alla difficoltà di definire cosa sia «malattia terminale» o ai cambiamenti psicologici che la malattia può innescare e che possono alterare anche radicalmente le precedenti convinzioni), pone il caso che ci si trovi nel futuro nell’incapacità di decidere o di comunicare le proprie volontà e che inoltre mette i medici nella condizione di eseguire volontà che sono state espresse, magari sommariamente e senza informazione, in un altro contesto e che potrebbero contrastare con il loro convincimento professionale e la loro valutazione del caso concreto, sfilacciando quella fiducia basilare nel rapporto tra medico e paziente; per non parlare del rischio che i trattamenti entrino in contrasto con quel «primo non nuocere» considerato la base della medicina e attribuito a Ippocrate, quando essi si traducano in vera e propria eutanasia, definita dalla World Medical Association come l’azione con cui «si pone deliberatamente fine alla vita di un paziente, anche nel caso di richiesta del paziente stesso o di un parente stretto»[25]. Nella recente assemblea di Berlino, l’associazione che riunisce 122 associazioni mediche del mondo, ha ribadito il suo netto rifiuto all’eutanasia e al suicidio assistito. In una nota la WMA dichiara l’inconciliabilità della professione con il dare la morte a un paziente e ricorda invece che nel fine vita devono essere accolti gli «aspetti fisici, psicologici, sociali, spirituali ed esistenziali» del malato, restando unico compito inderogabile del medico il garantire «un’assistenza medica di qualità»[26]. A parte la complessa questione detta del «pendio scivoloso», cioè il rischio che il suicidio assistito possa essere applicato anche in caso moralmente non ammissibili, è in gioco il significato stesso della medicina:
Il delicato equilibrio tra le opinioni dei pazienti, dei medici e della società può porre un dilemma etico, con il potenziale di esercitare un’influenza dirompente sulla santità della relazione medico-paziente e di distorcere negativamente il modo in cui la società percepisce il ruolo e le motivazioni degli operatori sanitari. Ad esempio, come considerato in precedenza, in particolare nei sistemi sanitari in cui i medici svolgono il ruolo di guardiani dell’assistenza sanitaria, il sostegno di un medico per una morte assistita per un malato terminale potrebbe essere interpretato negativamente come un conflitto di interessi, con il desiderio di contribuire ad alleviare l’onere sociale ed economico della malattia di un paziente sulla società che prevale sugli interessi individuali del paziente. In definitiva, se adeguate misure di salvaguardia dovessero essere implementate accanto alla legislazione pertinente, la morte assistita potrebbe rischiare di erodere l’integrità professionale dei medici[27].
Naturalmente anche nel mondo medico le posizioni sono le più diverse, tanto nel modo di intendere i doveri della professione, quanto i suoi limiti. Ne è esempio l’atteggiamento raccontato da Mario Riccio, anestesista che staccò il respiratore di Piergiorgio Welby, il quale ritiene di essersi assunto la responsabilità verso il suo paziente consentendogli di governare ancora un’ultima volta la propria vita[28].
Lungi dal giudicare chi è nella sofferenza e conosce, lui solo, la profondità del proprio patire, ci si deve sentire chiamati a una riflessione etica sui limiti di questa signoria dell’uomo sulla vita, propria e altrui, e sul rischio che esistano confini rotti i quali si apra la strada, anche solo in via teorica, a veri e propri abomini sorretti da una buona logica. Il principio va cercato e a esso va dato uno statuto forte, di contenimento della pericolosa ybris umana; ovvio è che il principio da solo non si regge senza il supporto di politiche fattive e di investimenti nel bene e non solo nel profitto. Faccia da esempio il grande progresso della medicina nel tenere in vita (o anche, talvolta, nel somministrare la morte) e nel curare il corpo, ma anche il suo regresso nella cura in senso ampio, in quel «prendersi cura» che dovrebbe includere anche le sofferenze psicologiche e spirituali, ancor più trascurate in reparti come la terapia intensiva dove la solitudine e il senso di smarrimento si acuiscono al massimo. Sebbene infatti – e non vi è dubbio – «l’aggressione» sia rivolta alla malattia e non al malato al fine di guarirlo, e l’isolamento sia una misura nell’interesse del paziente, così come l’utilizzo di macchinari sempre più sofisticati, ma al tempo stesso la medicalizzazione della malattia si estende inevitabilmente al processo del morire, rendendo la morte «innaturale» e «solitaria». L’isolamento del soggetto acuisce grandemente le sue sofferenze spirituali, che divengono forse più gravose di quelle fisiche, e l’eutanasia rappresenta, a questo punto, il disperato tentativo del malato di riappropriarsi della propria morte, sottraendosi al processo di depersonalizzazione[29].
È evidente che gli aspetti tecnici, non meno di quelli emotivi e strettamente bioetici, chiamano in causa e si riflettono nella giurisprudenza, che accetta la scelta della morte assistita con diverse gradazioni nei diversi Paesi[30].
Nell’approccio a un tema che riguarda ognuno e che interpella eminentemente la filosofia morale, non va dimenticato che nessun uomo vuole morire, ma certo vuole vivere e come ricorda il Comitato nazionale di bioetica il più delle volte «il problema centrale dei malati terminali è di natura non fisica, ma psicologico-spirituale»[31] e a essi vanno date risposte serie, fatte di sostegno nella malattia in termini economici, di servizi di assistenza a domicilio, strutture sanitarie attrezzate anche nell’accompagnamento di ciò che nell’uomo non è corpo: la sua psiche e la sua anima, quanto mai chiamate in causa al confine con l’esperienza estrema che ci fa mortali.
Se la morte è un fatto culturale, e l’idea di buona morte è relativa ai tempi e ai sistemi umani, va cercato qualcosa che supera i mutamenti delle mentalità e le differenze tra latitudini, perché l’idea che ci facciamo della morte rispecchia quella che abbiamo della vita, e rivela chi siamo al cospetto della storia.
[1] Cfr. E. De Martino, Morte e piano rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Torino, Bollati Boringhieri, 2008; Cfr. M. Eliade., J. Ries, Dizionario della vita, morte ed eternità, Jaca Book, Milano 2021; Cfr. P. Ariés, L’uomo e la morte dal medioevo ai nostri giorni, Laterza, Roma-Bari 1980.
[2] Cfr. A. M. Di Nola, La nera signora. Antropologia della morte e del lutto, Newton &Compton, Roma, 1995.
[3] Cfr. A. Tenenti, Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento, Einaudi, Torino 1989.
[4] L. A. Seneca, Lettere morali a Lucilio, (a cura di) F. Solinas, Mondadori, Milano 2018, p. 24.
[5] A. M. Di Nola, La nera signora. Antropologia della morte e del lutto, cit., p. 73.
[6] J.-P. Vernant, La belle mort et le cadavre outragé, In G. Gnoli, J.-P Vernant, La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, Cambridge University Press 1982, p.45.
[7] I Ts, 4, 13-14.
[8] I Cor, 15, 20.
[9] Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, Lettera enciclica sul valore e l’inviolabilità della vita umana, 2, San Paolo, Torino 1995; Cfr. Sacra Congregazione per la dottrina della fede, Dichiarazione sull’eutanasia, 26 giugno 1980, n. 2.
[10] Cfr. S. Kirkegaard, Aut-Aut, Mondadori, Milano 2016.
[11] Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005; M. Lo Conte, Esistenza e morte. Heidegger e Sartre, La Scuola di Pitagora, Napoli 2019.
[12] Cfr. J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 2014.
[13] P. Singer, Ripensare la vita, Il Saggiatore, Milano 1996, p.63.
[14] P. Singer, La vita come si dovrebbe, Il Saggiatore, Milano 2001, p. 13.
15 E. Sgreccia, Manuale di bioetica, I, Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 725.
[16]Platone, Leggi, (a cura di) F. Ferrari, S. Poli, Rizzoli, Milano 2005, IX, 873d.
[17] Epitteto, Manuale, tr. it. Menghi, Rizzoli, Milano 1996.
[18] Seneca, Lettere morali a Lucilio, (a cura di) F. Solinas, Mondadori, Milano 2018, XXIV, pp. 6-8.
[19] Tacito, Annales, XVI, pp. 18-19.
[20] Svetonio, Vite dei Cesari, a cura di Casorati F. I, Newton & Compton, Roma 2022, p. 99.
[21] R. Bultrini., Un cronista tra gli orrori di un’eutanasia all’indiana, in repubblica.it (accesso del 14/11/2022 a: https://www.repubblica.it/venerdi/reportage/2016/01/18/news/eutanasia_al_l_indiana_esteri_estremi_rimedi_esteri_estremi_rimedi-131526611/)
[22] G. Gorer, La pornografia della morte, In Encouter, 5, 4,1955, pp. 44 – 49.
[23] Comitato nazionale per la bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma 1995, pp. 66 – 67.
[24] M. L. Di Pietro., Tra testamenti di vita e direttive anticipate: considerazioni bioetiche, «I Quaderni di Scienza e Vita», 1, 2006, pp. 79-87.
[25] M. L. Di Pietro., Tra testamenti di vita e direttive anticipate: considerazioni bioetiche, p. 83.
[26] F. Ognibene, Wma. L’Associazione medica mondiale: fermo “no” a eutanasia e suicidio assistito, 10 novembre 2022, In Avvenire, https://www.avvenire.it/vita/pagine/medici-di-tutto-il-mondo-unitevi.
[27] A. Fontalis., E. Prousali., K. Kulkarni., Euthanasia and assisted dying: what is the current position and what are the key arguments informing the debate?, In «J R Soc Med.», 111, 11, 2018, pp. 407-413.
[28] Cfr. M. Riccio, Storia di una morte opportuna. Il diario del medico che ha fatto la volontà di Welby, Sironi,Milano 2008.
[29] Cfr. C. Manni, R. Gaddini De Benedetti, Eutanasia, in Universo del corpo, Roma, Treccani, 1999.
[30] A. Fontalis., E. Prousali., K. Kulkarni. (2018), Euthanasia and assisted dying: what is the current position and what are the key arguments informing the debate?, In «J R Soc Med.», 111, 11, 2018, pp. 407-413.
[31] Comitato nazionale per la bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, pp. 66 – 67.